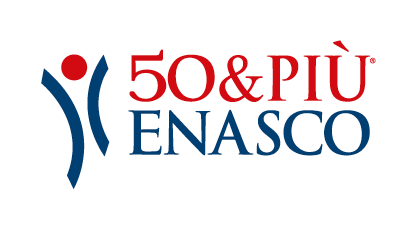Relazione del Presidente Sergio Billé all'Assemblea 1999
Relazione del Presidente Sergio Billé all'Assemblea 1999

Per guardare oltre la siepe che ci separa dal nuovo millennio e tentare di tracciare i possibili sbocchi futuri della nostra economia è arrivato il momento di dire cose che potranno essere piacevoli per alcuni ma, forse, assai spiacevoli per altri.
Ci sembra l'unico modo, questo, per non scadere in analisi solo virtuali.
L'unico modo per lasciare fuori della porta quella retorica delle progettualità ingannevoli che ha troppo condizionato, in questi anni, anche il rapporto tra il mondo della politica e le parti sociali.
Partendo da un assunto: sta tramontando nel nostro paese, come è già tramontato in altri, un certo modo di concepire e di fare mercato.
Chi non si accorge di questa fondamentale novità o fa finta di non vederla rischia di finire fuori corsa.
È già fuori corsa.
Cambiare moduli, tipologie di approccio - basta citare i problemi che si pongono in materia di flessibilità del mercato del lavoro - è diventata quindi per tutti, per chi fa impresa ma anche per chi fa politica e sindacato, non una semplice opzione ma un'inderogabile esigenza.
Ma esistono anche problemi di garanzia e di tenuta del tessuto democratico.
Il sacrificio di un uomo come D’Antona che aveva speso tutta la vita al servizio dello Stato e nello studio proprio di quella concertazione tra Stato e corpi sociali che è oggi diventato uno dei problemi centrali della nostra economia non può essere avvenuto invano.
Per ricordare il suo sacrificio invito questa Assemblea ad un minuto di silenzio.
Il primo dato che va analizzato è la fine, per chiosare il titolo di un famoso film di Jean Renoir, di una grande illusione.
L'illusione che l'Europa di Maastricht avrebbe potuto, come la fata Morgana, risolvere, per incanto, i problemi degli europei e quelli di noi italiani in particolare.
Per il nostro paese è stato assai positivo entrare in Europa anche se questo ingresso, come sa fin troppo bene chi è oggi in questa sala, è costato lacrime, sudore e sangue.
Ma va detto anche che, superata questa prova, ci troviamo ancora ai piedi di una montagna tutta da scalare: ripida, rischiosa, difficile come poche altre.
Perché non dirsi la verità?
Perché non dire che Maastricht, con il suo corredo di rigide regole e di patti di stabilità, ha fino ad ora risolto ben pochi dei problemi che abbiamo di fronte?
Un esempio?
Il fatto è che i 35 milioni di disoccupati che c'erano, in Europa, prima dell'avvento dell'Unione, ci sono ancora tutti. E c’è il rischio che tra poco ce ne saranno ancora di più.
Bel problema davvero per quei governi di sinistra, compreso il nostro, che sono stati chiamati a gestire la prima fase della nuova Unione europea!
E' insomma caduta l'illusione che la grande Europa dell'euro potesse diventare, a tambur battente, uno strumento politico capace di concertare strategie di sviluppo in difesa di quei mercati che sono diventati bersaglio della grande finanza anche speculativa, l'unica forza che abbia colto a volo i vantaggi della globalizzazione e realizzato i suoi progetti.
La guerra nei Balcani ha ulteriormente rallentato questo processo, al punto che siamo arrivati alla soglia dell'estate con un nuovo Parlamento europeo, per altro di composizione assai diversa dal precedente, con tutto o quasi ancora da fare.
E con i cittadini europei, occupati e non, sempre più preoccupati e scontenti di come stanno andando le cose nei loro paesi.
Anche la Banca Centrale Europea, con i suoi comportamenti rigidi, con la sua quasi ossessiva difesa della politica monetaria consentita da un articolo 107 del Trattato che avrebbe potuto essere meditato di più, ha innestato, come ha ricordato di recente Franco Modigliani, una specie di pilota automatico che sta bloccando ogni tipo di contributo da parte dei ministri economici dei paesi dell'Unione.
Un contributo, giudicato invece interferenza, di chi si sforza di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze dei poteri forti che manovrano la finanza e quelle dell'economia reale che ha bisogno di creare nuovi posti di lavoro e di un mercato che sia più competitivo sul fronte dei prodotti, dei servizi, delle tecnologie.
Il nostro paese, a causa delle sue deficienze strutturali, del suo gap tecnologico, della sua ingombrante spesa pubblica, sta peggio di tutti gli altri.
E la condizione di Cenerentola d'Europa in cui oggi ci troviamo è un altro dato mortificante.
Ciò ha costretto il nostro Governo a più attente riflessioni sull'urgenza di porre mano ad interventi di diverso conio che consentano alla nostra economia di uscire dalle secche in cui da ormai troppo tempo si trova.
Ma ci si è mossi troppo tardi, si è perso troppo tempo in politiche attendiste che hanno aggravato la situazione.
E ora rimontare la china è un problema.
Un problema per il Governo e le forze politiche che lo sostengono ma anche per tutto il paese e le sue forze imprenditoriali che stanno reagendo in modo visibilmente negativo, trasudando sfiducia da tutti i pori.
Il segnale che è venuto dalle elezioni europee e amministrative è, da questo punto di vista, forte e chiaro.
Ed anche il fatto che sia stato proprio un operatore del settore del commercio come Giorgio Guazzaloca, a cui va oggi il nostro caloroso saluto, a diventare sindaco di un’importante città come Bologna non può essere in alcun modo, sottovalutato o minimizzato.
Significa che le cose, in questo paese, stanno cambiando e anche abbastanza rapidamente.
Sembra che il nostro Governo si sia reso conto della gravità della situazione e, difatti, qualche nuovo segnale si intravvede nel Dpef che è stato appena presentato.
Ma sono segnali ancora flebili, di cornice che, per risultare più concreti e tangibili, dovranno trovare riferimento nella finanziaria a cui si porrà mano solo più avanti.
E così ci attendono altre settimane, altri mesi di incertezza.
Sinceramente troppi per chi attende da tempo quel segnale di ripresa del mercato che sembra non arrivare mai.
Il Governo è costretto a fare e rifare i conti cento volte perchè deve cercare di salvaguardare, come può, non solo le esigenze di bilancio ma soprattutto quelle, spesso contraddittorie tra loro, delle forze politiche che fanno parte della sua maggioranza o la sostengono.
E quando si è costretti ad imboccare la via dei compromessi è difficile fare scelte chiare in tema di politica economica.
Mi sembra che il Dpef appena varato dal Governo ne sia un esempio.
La verità è che ormai è dimostrato che non si può cambiare senza poi non cambiare quasi nulla, non si può più lavorare per la ripresa e lo sviluppo lasciando inalterate vecchie strutture, vecchie politiche di spesa, vecchie regole del mercato del lavoro.
Quando si comincerà a capire che il vecchio sistema Italia, quello che governa lo Stato sociale in primo luogo, si regge ormai su palafitte troppo logore, troppo rose dai tarli per poter sostenere la casa degli italiani negli anni duemila?
Nel marzo scorso, nel convegno di Cernobbio di Confcommercio, decisamente insoddisfatti per la mancanza di risultati del patto di concertazione siglato a Natale, avevamo deciso, come ricorderete, di staccare la spina: non ci sentivamo più di continuare ad avallare, in alcun modo, un patto sociale che non stava producendo effetti.
Oggi c'è stato chiesto di ritornare al tavolo del confronto, cosa che abbiamo fatto, ma la preoccupazione che si scivoli sulla strada dei vecchi compromessi di sempre in molti di noi permane.
Sono ormai due anni e anche più che con la fase due, quella che avrebbe dovuto introdurre misure ed incentivi per ridare slancio al mercato, si continua a giocare a mosca cieca.
La gente, il mercato, gli operatori, i risparmiatori non ne possono più di promesse che sembrano valide un giorno ma che poi scompaiono il giorno dopo.
E' davvero urgente, a nostro giudizio, un cambio di corsia per valorizzare finalmente, ad esempio, anche quel settore dei servizi che rappresenta forse oggi l'unica area imprenditoriale in grado di produrre nuovi posti di lavoro.
Cambiare corsia significa finalmente comprendere il ruolo centrale assunto oggi dal settore del terziario - produce da solo il 55% del prodotto interno lordo e il 60% dell'occupazione - nell'assetto della nostra economia.
Cambiare di corsia significa riconoscere a questo settore il peso, la valenza, il ruolo che certamente gli spettano e che sono ben maggiori di quelli che fino ad oggi gli sono stati riconosciuti. Spesso ad intermittenza.
Cambiare il sistema delle regole significa liberalizzare il mercato, privatizzarlo veramente, eliminare quelle bardature ottocentesche che lo Stato ancora mantiene ed impone, togliere molta zavorra a quella spesa pubblica che continua ad essere la vera palla al piede del nostro mercato.
Gli elettori hanno voluto che fossero governi di centro-sinistra e non di centro-destra ad affrontare e risolvere simili problemi.
L'importante è che questi governi riescano a risolverli entro breve tempo.
E, se no, si cerchino altre soluzioni perché il mercato non può attendere in eterno.
Il presidente del Consiglio, D'Alema, ha detto di recente che è indispensabile trasformare la burocrazia da potere in servizio per i cittadini.
Giusto, ma quando si realizza questo progetto?
Bisogna cambiare una buona volta il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino, tra politica e operatori economici, tra Ispettore delle Finanze e contribuente, tra chi ha in mano il compito di fare giustizia e chi la invoca senza mai riuscire ad ottenerla.
Cambiare significa "smontare" pezzo per pezzo il vecchio sistema e fare sì che il cittadino italiano non venga più trattato come suddito.
Un cittadino che ha torto anche quando ha ragioni da vendere.
Per anni, in questo paese, si è preferito tenere il mondo delle piccole e medie imprese e del lavoro autonomo in anticamera escludendolo da ogni tipo di reale concertazione.
Errore grave, madornale che sta costando caro anche a chi fa politica.
E perché lo si è lasciato sempre in anticamera?
Perché farlo diventare parte attiva della concertazione avrebbe voluto dire rompere certi vecchi equilibri;
- cominciare a discutere di mercato e di occupazione in altro modo;
- ridurre di fatto peso ed influenza di altre forze economiche e sindacali quando, al tavolo della concertazione, si trattava di fissare modelli di sviluppo e di spartirsi incentivi e settori privilegiati di investimento.
Il ministro del Tesoro, Amato, sostiene ora che questo paese ha accumulato, in questi anni, il massimo ritardo proprio nella crescita del settore dei servizi e delle tecnologie, l'unico in grado, egli dice, di creare il maggior numero di posti di lavoro.
E il Dpef ieri varato dal Governo insiste sulla necessità di abbattere quelle barriere fiscali, amministrative e finanziarie che impediscono la crescita del tessuto delle nostre piccole e medie imprese.
Analisi corretta. Ma non ci si poteva pensare prima ad abbattere queste barriere e a recuperare questo ritardo?
Bisognava per forza attendere l'ultimo dato Istat che assegna quasi al solo settore dei servizi i 280 mila nuovi posti di lavoro creati in quest'ultimo anno per rendersi conto di una realtà che esisteva già da molto tempo?
Pur di non far scendere il Terziario dal loggione e riconoscergli il ruolo che gli era dovuto si sono usati mille espedienti. Come quello di affidare il volano della crescita del sistema economico solo al recupero di competitività delle imprese export-oriented.
Ma anche il mito dell'export sembra essersi offuscato:
- sia per la caduta della domanda mondiale e della crisi che ha colpito i paesi del Sud Est asiatico e che ora colpisce, in maggior misura, anche i paesi dell'ex Unione Sovietica e quelli del Sud America;
- perché i nostri prodotti, a causa dei sempre più alti costi di produzione derivanti soprattutto dall'eccessiva pressione fiscale e previdenziale, sono diventati oggi assai meno competitivi e rischiano, in un regime sempre più vasto di globalizzazione e di competizione tra i mercati, di non riguadagnare più i livelli di un tempo.
Oggi i nostri prodotti possono essere realizzati in altri paesi ad un terzo, ad un quarto, ad un quinto del costo che hanno in Italia. E così il "made in Italy" rischia di perdere fette di mercato che prima erano una nostra fonte di ricchezza.
Per tutte queste ragioni è assai difficile che, alla fine di quest'anno, il nostro prodotto interno lordo possa raggiungere la soglia dell'1% mentre gli investimenti aumenteranno solo del 2,4% e le esportazioni avranno sicuramente un risultato negativo.
La caduta delle esportazioni, se si fa un confronto tra il primo trimestre di quest'anno e quello dell'anno precedente, è stata rilevante in molte regioni: -12,1% in Lombardia, -10,3% in Piemonte, -7,7% in Liguria, -6,8% nel Veneto, -26,8% nelle Marche, -37,2% in Sicilia. In altre regioni del Sud, come, ad esempio, in Basilicata, il dato è più positivo ma la media resta assai negativa.
Sono dati che purtroppo parlano da soli.
La crisi dell'export ha avuto riflessi anche sui livelli occupazionali delle grandi e medie imprese che, difatti, non hanno creato nuovi posti di lavoro, anzi ne hanno perduti.
Per questo andiamo sostenendo da tempo che il problema primario, per rimettere la nostra economia sui binari dello sviluppo, è quello di far ripartire la domanda interna sia nella componente dei consumi sia in quella degli investimenti, l'unico modo per far ripartire, di sponda, anche tutto il resto, export compreso.
Occorrono provvedimenti che alleggeriscano, da un lato, la pressione fiscale sulle aziende come sui consumatori e, dall'altro, aiutino le piccole e medie imprese che operano sul mercato interno ad uscire da quel tunnel di stagnazione in cui si trovano da fin troppo tempo.
E’ anche importante che possa essere rinnovato, a giuste condizioni, il contratto nazionale per i lavoratori del Terziario, un settore che ha bisogno di aumentare la sua produttività legandola alle mutate condizioni del mercato e alle nuove regole, ad esempio in tema di orari, che sono state fissate.
Con il problema fiscale si è giocato a rimpiattino per mesi e mesi sperando che Sant'Antonio per il Nord Est, Sant’Ambrogio per il Nord Ovest, San Pietro per il Centro e San Gennaro per il Sud facessero il miracolo di una ripresa che potesse arrivare quasi per germinazione spontanea.
Illusioni, nient'altro che illusioni.
L'attesa ripresa del secondo trimestre del '99 rischia di risultare così inferiore alle aspettative.
Occorre anche ampliare - e sappiamo bene di toccare un altro tasto dolente - il campo di intervento di politiche che siano in grado di operare tagli significativi alle spese correnti eliminando non solo ogni forma di spreco e di inefficienza, ma intervenendo anche, in modo più incisivo e strutturale, sulla spesa previdenziale e pensionistica.
E così non possiamo non parlare anche di quella ipotesi di riforma delle pensioni che è diventata la lama rovente dello scontro di questi giorni tra Governo e Sindacati.
Non ci dispiace aver fatto in qualche modo da apripista su una questione che, a nostro giudizio, non poteva più essere lasciata nel cassetto.
E chi ora propone di rimetterla nel cassetto, per motivi di opportunità, commette un errore.
Quando le pensioni di anzianità furono varate, avevano, tra gli altri, l’obiettivo, da un lato, di assicurare il giusto riposo anche a chi, a cinquant'anni, si sentiva già logorato dal lavoro e di liberare, dall'altro, per i giovani nuovi spazi occupazionali.
Purtroppo questa riforma, a quasi 30 anni di distanza, si è rivelata una mezza illusione perchè chi è andato in pensione prima del tempo si è messo a fare qualcos'altro, lasciando scarsi spazi per nuovi posti di lavoro.
E quel che è accaduto nell'area del pubblico impiego ha avuto, da questo punto di vista, conseguenze anche peggiori.
E' chiaro quindi che problemi come questo e come altri che si chiamano cambiamento della struttura produttiva, allungamento della vita media, natalità ormai vicina allo zero vanno affrontati con fermezza, con decisione, con un nuovo bagaglio di idee e di progetti.
Per quanto riguarda la riforma delle pensioni noi siamo pronti al confronto ma a due inderogabili condizioni:
- la prima è che anche le altre parti sociali siano disponibili allo stesso tipo di confronto;
- la seconda è che questa riforma preveda per il settore del lavoro autonomo reali e adeguate contropartite.
I Sindacati sostengono invece che nulla debba essere cambiato prima della naturale scadenza del 2001.
Ci sia consentito di dire che la posizione dei sindacati ci sembra troppo attendista per due motivi.
Primo, perché essa non tiene conto dello stravolgimento - e stravolgimento è dir poco - intervenuto nel sistema economico nel corso di questi ultimi anni, un'economia che ha cambiato pelle, parametri, punti di riferimento, livelli di concorrenza, insomma quasi tutto.
Secondo, perché rinviare ancora un problema come quello delle pensioni significa di fatto non avere le risorse e i margini di manovra necessari per cambiare non tanto la quantità ma la qualità della spesa sociale e per realizzare quel passaggio dal Welfare al Workfare che rappresenterebbe la vera conquista di un sistema economico che voglia guardare avanti.
Una manovra sulle pensioni non è di per sè sufficiente a far svoltare questo paese. Bisogna fare molte altre cose e farle in fretta ed in parallelo.
Bisogna affrontare prima di tutto il problema fiscale, un vero e proprio macigno che ostruisce oggi la via dello sviluppo.
Sono stati spesi sull'argomento fiumi di parole ma non è stato fatto ancora nulla che stimolasse il mercato a crescere, ad investire, a riprendere la via dei consumi.
La verità è purtroppo una sola: la pressione fiscale continua a mantenersi su livelli troppo elevati nonostante il decremento di un punto in percentuale del Pil: dal 44,2% del 1997 al 43,2% del 1998.
Occorre altresì considerare:
- che oltre la metà della riduzione della pressione fiscale avvenuta nel 1998 è del tutto involontaria perché imputabile all’errore di previsione sul gettito dell’ IRAP;
- che gli enti locali hanno appena iniziato ad utilizzare le opportunità di aumento del prelievo tributario loro attribuite dalla recente riforma fiscale (addizionali regionali e comunali all’IRPEF, IRAP, canoni, ICI, ecc.);
- e soprattutto che il PIL dell’Italia viene rivalutato di circa il 15% per tener conto dell’economia sommersa.
Poichè quest'ultima, per sua natura, viene toccata solo in minima parte dai tributi, la pressione fiscale e contributiva effettiva sui redditi dichiarati risulta essere così almeno del 50%, cioè ben superiore a quella che risulta dalle statistiche ufficiali e più coerente invece con quella derivante dall'esperienza comune dei lavoratori e delle imprese dalle quali lo Stato viene oggi definito una specie di non gradito, anzi fastidioso, "socio occulto al 50%".
Così non si può più andare avanti. La classe politica se ne rende sufficientemente conto?
In questo modo la nostra economia rischia di fare il passo del gambero e di restare poco competitiva sui mercati; di essere un europaese solo nominale.
Dalla metà degli anni ottanta, le politiche fiscali dei paesi dell'euro hanno imboccato strade profondamente divergenti, con effetti assai diversi in termini di pressione fiscale, di crescita del PIL, di disoccupazione e di inflazione.
Da un lato, ci sono i tre principali Paesi europei per popolazione e livello del prodotto interno lordo, cioè Francia, Germania e Italia, che hanno visto crescere la pressione fiscale, nel periodo 1985-1998, di oltre 5 punti percentuali, attestandosi, nell'ultimo anno, sulla media del 44,2% del PIL.
Ma è la media del pollo di Trilussa perché per l'Italia il salto è stato non di 5 ma di 9 punti. Sinceramente troppi per un sistema dissestato come il nostro.
Dall'altro, ci sono paesi come l'Irlanda, la Spagna e il Regno Unito che hanno mantenuto, addirittura ridotto, come nel caso dell'Irlanda e del Regno Unito, il livello di prelievo tributario e contributivo rispetto al PIL attestandosi oggi poco al di sopra del 35%.
E' vero che, in questi Paesi, il livello del debito pubblico è decisamente inferiore, ma è anche vero che essi hanno saputo attuare politiche di mercato più coraggiose e più moderne di quelle di altri Paesi.
E poi un'altra considerazione: è vero che Francia e Germania hanno una spesa pubblica elevata ma è anche vero che entrambi questi Paesi dispongono di strutture, di infrastrutture e di servizi che aiutano l'economia a guardare avanti e a sopportare meglio il peso anche di situazioni congiunturali non facili.
In Italia queste strutture di sostegno del mercato o non ci sono o funzionano a senso unico creando il deserto intorno al settore delle piccole e medie imprese.
E difatti da noi non è in crisi solo l'occupazione ma anche la fiducia degli imprenditori che, se hanno soldi da investire, preferiscono investirli all'estero e dei risparmiatori che preferiscono tenere i soldi sotto il materasso.
Il forte tasso di crescita delle entrate negli ultimi anni in altre parole non fa parte di una visione più globale e condivisa socialmente sul ruolo e sulle funzioni dello stato come è nei paesi a lunga tradizione di welfare; essa viene invece vissuta dal sistema economico italiano come un dato estraneo ed imposto, a cui peraltro non fanno riscontro nemmeno adeguate contropartite né in termini di sicurezza sociale né in termini di efficienza amministrativa.
E si assiste all'assurdo di un sistema imprenditoriale basato su centinaia di migliaia di piccole aziende che, a causa di un opprimente sistema fiscale e contributivo, non riescono a crescere e soprattutto a capitalizzarsi.
Un sistema fatto da micro aziende costrette, loro malgrado, a restare tali.
Il contribuente paga sempre di più servizi che lo Stato e le Amministrazioni continuano a non erogare, paga il conto giornaliero di una spesa pubblica che non riesce ad essere diversamente orientata e strutturata.
L’apertura dei mercati ed i processi di integrazione in atto nella Unione Europea stanno determinando una crescita senza precedenti dei livelli di concorrenza all’interno del terziario di mercato, che pure dà lavoro a 10 milioni 312 mila unità, pari al 45,4 per cento degli occupati totali.
I segnali di questo cambiamento si registrano già da alcuni anni.
I settori del commercio, del turismo e dei servizi alle famiglie ed alle imprese non potranno non risentire delle dinamiche economiche in atto anche per la loro diretta dipendenza dalla domanda interna.
L’andamento del turismo 1998 è stato complessivamente soddisfacente in termini di flussi di visitatori, ma molto meno con riferimento ai flussi valutari: inferiori del 3,9% rispetto a quello del ’97.
Un ruolo pesante ha avuto la contrazione dei flussi provenienti dai paesi extraeuropei, ed in particolari asiatici, in conseguenza della crisi che ha colpito queste economie.
Infatti le entrate provenienti dal solo Giappone si sono ridotte quasi del 20%.
Bisogna però capire che il mercato turistico è in forte sviluppo a livello mondiale e molte località extra europee attirano crescenti flussi finanziari.
E’ necessario, perciò, che nel nostro Paese si varino, senza ritardi, consistenti programmi nel campo infrastrutturale e dei servizi complementari.
Altrimenti si corre il rischio non soltanto di non sfruttare adeguatamente le potenzialità del settore ancora inespresse, in particolare nel Mezzogiorno, ma anche di perdere consistenti quote di domanda sia interna che estera.
Dal canto suo, il settore del commercio nei prossimi anni sarà condizionato non solo da un’evoluzione della domanda delle famiglie ancora sostanzialmente contenuta, ma anche dagli effetti della riforma legislativa il cui impatto sulle imprese non è ancora valutabile.
Un dato è certo.
La necessità di competere diventerà sempre più stringente determinando l’esigenza di risorse finanziarie aggiuntive volte a migliorare l’offerta distributiva.
Le risorse per gli investimenti non sono tanto un problema delle grandi imprese, per le quali il ricorso al credito ordinario o l’autofinanziamento sono comunque meno onerosi, ma soprattutto delle piccole che dovranno anch’esse essere messe in condizione di attuare processi di modernizzazione e riqualificazione dell’offerta commerciale.
Un commercio non basato sulla professionalità è destinato ad avere vita corta.
Le condizioni necessarie alla buona riuscita della legge, un coordinamento tra Governo, Regioni, Comuni e Associazioni di rappresentanza ed un metodo di concertazione, si sono rivelate, alla prova dei fatti, deludenti.
Si vive un clima di estrema confusione ed incertezza tra le imprese ed all’interno delle istituzioni, in particolare, quelle locali.
Non si può fare a meno di rimarcare un certo atteggiamento di pregiudizio nei confronti di chi, come noi, ha messo in evidenza il preoccupante evolversi della situazione, proponendo soluzioni alternative.
Ci si è opposti ad ogni ipotesi di correzione del decreto, nei tempi previsti.
Il risultato è che adesso si sta tentando di svuotare con un secchio il lago, rimediando, in via interpretativa, con circolari e risoluzioni, alle lacune di carattere legislativo.
Ad oggi, la sola Regione Friuli-Venezia Giulia possiede una legge attuativa della riforma approvata e pubblicata.
Il termine del 24 aprile 1999, fissato quale data ultima per l’avvio della fase applicativa della riforma, è abbondantemente scaduto, ed è stato anche scavallato l’ulteriore termine del 24 giugno concesso, informalmente, dal Governo alle Regioni.
In realtà le Regioni, nonostante le serie difficoltà riscontrate nell’interpretare le nuove regole, si sono date da fare in questi mesi approvando, quanto meno in sede di Giunta, i nuovi testi normativi, testi che, in parecchi casi, hanno anche superato l’esame dei rispettivi Consigli Regionali.
I Commissari di Governo stanno, però, procedendo, così come già era avvenuto per il Friuli, a rinviare al mittente le leggi approvate, contestando nel merito le scelte fatte dai Consigli Regionali.
Ad oggi, il Veneto, la Basilicata e la Toscana sono “sotto esame”, ed i rilievi governativi vertono sempre ed unicamente sulle valutazioni operate dalle Regioni rispetto ai modelli di sviluppo individuati per i propri territori.
Decidere se un determinato indice di presenza, in relazione ai diversi assetti socio-economici ed urbanistico-commerciali dei propri territori, sia o meno congruo ad una specifica realtà territoriale, non può che essere compito di chi detiene il governo di quel territorio, e che, proprio in virtù del mandato conferito, deve disegnarne le coordinate in termini di sviluppo.
La presunta giustificazione giuridica, secondo cui le Regioni avrebbero “sforato” rispetto alle competenze loro delegate, non regge ad un’analisi attenta dei rilievi mossi.
E’ arrivato il momento di chiarirsi le idee, perché gli amministratori locali evidenziano le medesime difficoltà ed incertezze degli imprenditori, e, pur di evitare di incorrere in errori o illiceità vari, semplicemente, evitano di agire. Così si blocca l’intero sistema.
Le questioni legate ai saldi, alle vendite promozionali ed a quelle di liquidazione, agli orari ed all’individuazione dei comuni ad economia turistica, ai subingressi ed alle cessazioni di attività, rappresentano solo una piccola parte delle difficoltà giornaliere, che, da un lato, preoccupano e, dall’altro, impediscono di poter contare su regole certe.
Il previsto regolamento del sottocosto langue in qualche cassetto di cui non si è più certi chi ne possegga la chiave.
Sul sottocosto emerge, però, che in quasi tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea esiste una legge che fa divieto, tranne alcune ben determinate eccezioni, di vendere sottocosto. Il Governo italiano è intenzionato a seguire l’esempio degli altri partner europei?
Per superare questo panorama deludente, occorre moltiplicare le occasioni di consultazione e proposta, accelerare l’approvazione delle norme attuative senza la pervasività governativa nell’ambito delle scelte di merito operate dalle singole Regioni, riprendere il filo delle politiche attive.
Vale poco una riforma senza le risorse necessarie a sostenerne il decollo.
Le risorse saranno forse disponibili quando chi doveva chiudere ha ormai chiuso, chi aveva bisogno di un aiuto per associarsi ha magari rinunciato a farlo e chi aveva necessità di un sostegno per migliorare i sistemi gestionali, la logistica, gli approvvigionamenti non sa dove rivolgersi? Sono ancora fermi i Centri di assistenza tecnica, non costituite le società finanziarie e solo annunciati gli indennizzi, ridotti e pure di molto rispetto alle promesse.
Eppure la voglia di rinnovamento che il commercio sa esprimere è dimostrata dal fatto che in un mese, o poco più, sono andati esauriti i 250 miliardi stanziati due anni fa e disponibili per quest’anno per il rinnovo dei beni strumentali.
I meccanismi istituzionali di incentivazione che funzionano, in particolare quello relativo alla legge 488, pur con la prevista apertura al settore operata dalla scorsa legge finanziaria, ancora non possono essere applicati al commercio.
Mentre l’Unione europea provvede ad inserire la distribuzione nell’ambito della nuova programmazione dei fondi strutturali (2000-2006), il Governo italiano ne riconoscerà la rilevanza in termini di sviluppo, fatturato ed occupazione?
Il commercio italiano sta dimostrando una grande voglia di rinnovamento anche indotta dalla sfida della liberalizzazione e per fare questo non chiede di essere assistito, non si trincera più in funzione difensiva e corporativa, dietro il baluardo delle barriere all’ingresso, ma egualmente non viene messo nella condizione di poter competere.
Ma torniamo a temi di carattere più generale.
Dobbiamo anche disfarci una buona volta di quella cultura delle rendite improprie che per troppo tempo ha ingabbiato e frenato ogni processo di sviluppo e di trasformazione della nostra economia.
Quali sono queste rendite improprie?
- Quelle che hanno permesso a certi settori imprenditoriali di godere di benefici e di incentivi che invece erano preclusi ad altri;
- quelle che hanno consentito alle confederazioni sindacali di controllare, in toto, il mercato del lavoro impedendo che esso si potesse dare regole più flessibili e più idonee ad affrontare il problema dell'individuazione di nuovi posti di lavoro al di fuori dei vecchi e tradizionali canoni. Ci si perde in discussioni che poi non approdano mai ad un risultato. Un esempio? Si continua a discutere di Statuto dei lavoratori e di superamento della legge 108, quella che disciplina i diritti sindacali per le imprese minori, ma non si riesce a trovare un punto di accordo. E intanto il tempo passa e la situazione peggiora;
- quelle che hanno consentito al sistema bancario quando era una prevalente struttura pubblica di fare per anni una politica del credito aperta solo a determinate aree produttive, attenta soprattutto all’area dell’economia controllata dallo Stato;
- quelle che hanno, di fatto, rallentato oltre il lecito il processo di privatizzazione delle nostre strutture economiche e di servizio, concausa perenne del nostro deficit pubblico;
- quelle che hanno tarpato le ali a quel tipo di formazione professionale che avrebbe potuto, se sufficientemente potenziata e strutturata, dare a molti giovani quella "chance" occupazionale che oggi non hanno e che costringe loro ad inseguire mortificanti quanto inutili concorsi pubblici per strappare magari - anche se hanno un titolo di scuola superiore o addirittura una laurea - un posto di bidello o di usciere;
- quelle che hanno impedito che, nella nostra scuola, venissero potenziate le facoltà di informatica perché una simile trasformazione avrebbe dato fastidio alle tante baronie che ancora oggi regnano nelle nostre strutture formative. Cito per tutti un esempio: la facoltà di informatica dell'Università "La Sapienza" di Roma, costretta ad operare in una specie di scantinato proprio di fronte alla strada dove le nuove BR hanno poco tempo fa ucciso D'Antona, è sull'orlo della chiusura per mancanza di fondi e di docenti.
Pochi giorni fa la Corte dei Conti ha ribadito a chiare lettere che la “sperperosa” improduttività della Pubblica Amministrazione costa al sistema paese almeno 8 mila miliardi.
Delle due l'una: o la Corte dei Conti è una struttura dotata di armi che sparano solo a salve e allora non si vede il motivo per tenerla ancora in piedi e per affidarle compiti istituzionali così importanti come il controllo della spesa pubblica, o conta qualcosa e allora non si capisce perché non si comincino a fare le cose che essa chiede e sollecita da diverso tempo.
Ma ci sono altre cause.
Esse riguardano le difficoltà che incontra la nostra classe politica a mettere mano a riforme istituzionali che eliminino, o almeno riducano, quei fattori di vulnerabilità e di cronica precarietà che bloccano oggi il nostro sistema democratico.
Mi riferisco, in primo luogo, alla necessità di una riforma elettorale che metta finalmente la parola fine a quella polverizzazione del sistema dei partiti che sta sempre di più intralciando la costruzione di un sistema-paese che garantisca non solo i processi di sviluppo del quadro economico ma tuteli in modo più vigoroso e trasparente i diritti del cittadino.
Mi riferisco a quei correttivi da introdurre nella struttura dell'ordinamento democratico che consentano alla maggioranza che esce dalle elezioni e all'esecutivo che essa esprime di operare in maniera più incisiva e più certa per la realizzazione dei suoi programmi.
E mi riferisco a quella riforma delle istituzioni che faccia finalmente uscire il federalismo dal libro dei sogni e consenta l’elezione diretta del Presidente delle Regioni.
Senza dare alle strutture che operano sul territorio una reale autonomia e un reale potere di intervento il nostro sistema rischia di avvitarsi in un centralismo inconcludente, liberista solo a parole, moderno solo nella facciata.
Per questo ritengo doveroso rivolgere un accorato appello anche a chi è oggi in questa sala: ai rappresentanti del Governo, al capo dell'opposizione, Silvio Berlusconi e a tutti gli esponenti politici che ci hanno voluto onorare della loro presenza, perchè si riprenda al più presto su questi temi la via del dialogo e del confronto.
Sono quasi otto anni che si discute su questi temi senza riuscire mai a mettere un punto fermo. Non è più possibile continuare in questo modo.
La gente tra un pò, se le cose non cominceranno a cambiare, non andrà più a votare. Il crescente astensionismo è, in questo senso, qualcosa di più di un segnale.
Vogliamo forse che questo processo di crescente disaffezione continui?
Se appare miope chi rifiuta aprioristicamente di affrontare oggi il problema pensioni, non meno criticabile è chi mostra scarso interesse nei confronti di un'altra riforma che non può attendere, quella che consenta di dotare il mercato del lavoro di maggiori e più concreti strumenti di flessibilità.
Quando si parla di flessibilità non si può pensare soltanto a strumenti che facilitino l'ingresso o l'uscita di addetti dalle aziende.
E' indispensabile anche che le nostre imprese, soprattutto le piccole e le medie, abbiano un quadro di riferimento più chiaro, adempimenti che siano semplificati al massimo, controlli più logici e coordinati che non blocchino sul nascere le potenzialità di crescita aziendali.
E' assurdo fare muro - oggi questo muro lascia pochi varchi - a quei rapporti di lavoro atipici che il mercato sempre più richiede.
Occorre un sostanziale ripensamento delle modalità di apprendistato, occorre impostare politiche di formazione che siano pensate per tutte le componenti del mondo produttivo con riguardo sia al lavoro dipendente che al lavoro d'impresa e a quello autonomo.
Il patto tra generazioni che fino ad ora ha, in qualche modo, sostenuto il nostro sistema pensionistico deve essere applicato anche al mercato del lavoro.
Per questo va favorita e incentivata la collaborazione tra imprenditori che operano nei settori terziari e giovani che aspirino ad entrarvi.
Tutto quel che serve a muovere il mercato e a diventare una possibile leva di sviluppo va in ogni modo sollecitato.
Riformare il mercato e svilupparne le potenzialità significa anche mettere mano a programmi che incentivino l'innovazione tecnologica considerata uno dei fattori che ha maggiormente contribuito a sostenere gli elevati tassi di crescita di economie come quella statunitense.
Noi siamo, in questo settore, in notevole ritardo e questa è una delle cause primarie, anche se non la sola, della stagnazione dei nostri livelli occupazionali.
Se oggi Cofferati fosse presente, gli diremmo: non è colpa nostra, caro Cofferati, se il sistema economico ha sempre meno bisogno di metalmeccanici e sempre più bisogno invece di operatori del terziario.
E gli diremmo anche che il lavoro flessibile non può essere considerato artificiale solo perchè non garantisce più posti di lavoro che durano tutta la vita.
Persino l'economia giapponese che, per decenni, aveva puntato, per la sua crescita, su posti sicuri e inalienabili, è stata costretta oggi a fare marcia indietro e a cambiare strada.
La verità è che un'economia che corre ai ritmi di una sempre più sfrenata competizione e globalizzazione, presenta opportunità fino a ieri neanche immaginabili ma non paga più polizze a vita a nessuno. Nè alle imprese nè a chi vi lavora.
Forse che il Regno Unito, il paese dove il tasso di flessibilità del mercato del lavoro supera il 70% è, per questo, meno democratico, meno garantista dei diritti dei lavoratori, meno moderno del nostro?
E come mai, in questo paese, il tasso di disoccupazione non supera oggi il 4% mentre da noi è abbondantemente oltre il 12%?
E se oggi fosse qui D'Antoni, gli diremmo che, nel nostro paese, è ormai chiaro a tutti che c'è sempre meno bisogno di impiegati statali vecchio stile e sempre di più, invece, di operatori che, nelle privatizzande aziende. sappiano gestire servizi che richiedono altri tipi di professionalità e di specializzazione.
Che senso ha mantenere ancora, nella Pubblica Amministrazione, cattedrali dello sperpero che non creano servizi e, che, per il loro costo, aggravano oltre misura la spesa pubblica impedendo di stornare denaro per investimenti più produttivi, i soli che possono oggi creare nuova occupazione?
Abbiamo 300 mila ministeriali romani, 2 milioni e mezzo di dipendenti pubblici e spendiamo circa un quarto del PIL per amministrare un paese che sarà sempre più amministrato da Bruxelles.
E se oggi fosse qui Larizza, gli diremmo: dove porta tanta rigidità nei confronti di un mercato del lavoro che o cambia o non porta più da nessuna parte?
L'informatica, in questo paese, ha fatto passi da gigante nel settore finanziario ma è invece imperdonabilmente in ritardo in altri settori, quali, ad esempio, quello commerciale e turistico, che pure sono i soli ad offrire oggi notevoli potenzialità occupazionali.
E' altrettanto evidente che un più diffuso impiego delle nuove tecnologie nei processi aziendali di tale tipologia di imprese, può rappresentare un indispensabile fattore di incremento di efficienza e di competitività.
Per anni si è pensato che costruire auto e solo auto fosse l'obiettivo primario del nostro modello di sviluppo.
Umberto Agnelli, intervenendo al nostro convegno di Cernobbio, ha detto che è ora di dare spazio e nuovo impulso a tutte quelle imprese che operano nel settore dei servizi.
Giusto. Ma quando si comincia, con convinzione, una politica mirata ad obiettivi così innovativi?
La necessità di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese alle nuove tecnologie assume oggi una valenza prioritaria di politica economica come lo è nel campo dei servizi e delle infrastrutture.
E' in quest'area che può crescere la nuova occupazione. E' da quest'area che può svilupparsi un progetto come quello del commercio elettronico destinato ad avere, a medio termine, una sicura espansione.
Proviamo a tirare le fila del nostro ragionamento.
In Italia, ha detto recentemente Giuseppe Tesauro, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, continua a pesare un fattore culturale negativo, quello della massiccia presenza dello Stato dappertutto che ha portato anche ad una regolamentazione invadente.
E le regole, dice Tesauro, quando non sono necessarie, producono solo danni.
Vero. Ed è anche peggio quando si cerca, come nel caso della riforma del commercio, di liberalizzare un settore, abbattere certe regole, ma ci si dimentica, non si vuole, non si riesce a liberalizzare tutto quel che di rigido e di statalista c'è ancora intorno ad esso.
E' questo un liberismo a senso unico che, invece, di risolvere i problemi, può aggravarli ancora di più.
Non è l'economia ad andare in pensione ma sicuramente un certo modo di concepirla.
Non è il mercato del lavoro che soccomberà, ma un certo modo di gestirlo e di programmarlo: o questo modo cambierà adattandosi alle esigenze della nuova economia o, in pensione anticipata, dovranno, prima o poi, andare i cattivi programmatori.
La cosa straordinaria e alquanto assurda è che questo paese, se volesse, potrebbe farcela.
Dispone di risorse immense - basti pensare al suo eccezionale patrimonio di beni culturali, il più ricco del mondo - di imprenditori dotati di fantasia, estro, voglia di competere e di primeggiare.
Ma bisogna smetterla di mortificare queste nostre attitudini, bisogna smetterla di considerare l'economia e il mercato una variabile dipendente da altri fattori che, in un paese proiettato verso il Duemila, non hanno proprio più diritto di cittadinanza.