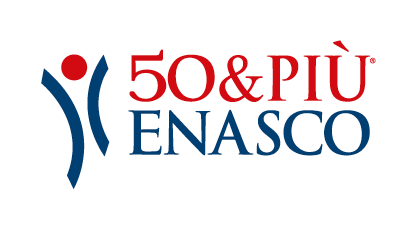LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO SERGIO BILLÈ
LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO SERGIO BILLÈ

Autorità, Signore, Signori, Signori Associati
il nostro paese deve oggi sopportare un carico di problemi assai rilevante.
A quelli che ci portiamo dietro da tempo - e sono tanti - se ne sono aggiunti altri. E di nuovo conio, di maggior spessore e più difficili da risolvere.
Anche per questo si è creato, nel paese, un clima di palpabile e diffusa incertezza.
Vorremmo poter guardare al futuro in positivo.
Ma purtroppo non ci sono segnali che possano ancora supportare questo ottimismo. Non sappiamo nemmeno se il 2004 potrà davvero essere finalmente l’anno della svolta e del rilancio.
L'andamento dell’economia continua, infatti, ad essere troppo condizionato da variabili per la maggior parte esterne al nostro sistema.
Anche per questo quel che un giorno sembra essere ormai a portata di mano, il giorno dopo torna bruscamente ad allontanarsi. Sono più di due anni che viviamo sopra questa specie di ottovolante.
C’è chi ci sta facendo l’abitudine e chi no.
La verità è che siamo ancora nel pieno di una crisi turbinosa che coinvolge non solo tutti gli asset dell’economia mondiale ma anche le stesse Istituzioni.
E' come se fossimo stati paracadutati su un altro pianeta dove c’è carenza d’ossigeno.
E’ una crisi che sta avendo anche un forte impatto sociale.
Perché essa ha creato nuove paure e, nel contempo, risvegliato vecchie e mai rimosse frustrazioni.
Sta prendendo corpo un senso di precarietà: oggi sta andando male, ma domani potrà andare davvero meglio?
Per questo molte famiglie si sono messe a vivere oggi nell'autarchia spendendo solo l’indispensabile.
E ci sono motivi plausibili perché, solo nell'ultimo anno, il rendimento dei loro redditi da capitale è calato dell’11%.
Per uscire da questo torrido clima che non promette nulla di buono è indispensabile che ci sia, da parte di tutti, un forte scatto di orgoglio.
Prima di tutto da parte di chi ha oggi, nel paese, ruoli e responsabilità primarie.
Nessuno nega l’importanza che, in una democrazia, può avere anche un acceso confronto politico.
Ma quando questo confronto degenera in una continua, sfibrante, quotidiana, quasi isterica lotta senza quartiere, allora, ad andarci di mezzo, non è la politica ma tutto il paese.
Maggioranza ed opposizione devono, insomma, riuscire a trovare, almeno su alcuni dei punti nodali della crisi che stiamo vivendo, qualche forma di intesa o almeno di non belligeranza.
E lo devono fare presto, subito, ora, prima che la corda si spezzi.
Prima che famiglie, operatori economici ed imprese, nevrotizzati, esasperati dal cumulo di tensioni che la politica partorisce ogni giorno ma che non producono alcun vantaggio concreto per il paese, comincino a voltare le spalle alle stesse Istituzioni.
E questo sarebbe un risultato davvero sciagurato.
Fino a qualche anno fa - prima degli attentati dell’11 settembre, il primo di quei forti attacchi epilettici che hanno sconvolto il sistema - sembrava credibile e alla portata di tutti un progetto economico fondato solo su alti, diffusi e costanti tassi di crescita.
Ora questo progetto è scomparso da tutti gli schermi. Anche da quelli delle famiglie. Ed è inutile cercare di fare zapping con il telecomando perché questo progetto non lo ritroviamo più su nessun canale.
Il fatto è che i binari della globalizzazione, costruiti, e con grande enfasi, per far meglio scorrere i processi di liberalizzazione e di sviluppo dei mercati, sono stati utilizzati da chi perseguiva disegni diversi, anzi opposti.
Quelli cioè di creare, nel mondo, non maggiore benessere ma nuove e sempre più dirompenti forme di tensione e di conflittualità.
Il terrorismo si è trasformato in un micidiale strumento anche di guerra economica.
La mancanza di strutture di governance che garantissero scudi di protezione ai processi di sviluppo ha reso ancora più traumatico lo scontro fra queste due realtà.
Inoltre - paradosso dei paradossi - proprio perché ha potuto scorrere sui binari della globalizzazione, il processo di deterioramento della congiuntura ha finito con il contagiare rapidamente tutte le aree del mondo.
Ed è un virus che ha fatto più danni dell’epidemia della SARS.
Tutto questo certamente un giorno dovrà finire, ma per il momento nessuno è ancora in grado di dirci quando e come finirà e chi da questa guerra economica potrà trarre alla fine maggiori vantaggi.
Sono in affanno, a cominciare da quella degli Stati Uniti, le economie di mezzo mondo.
Istituzioni come l’Onu, il Fondo monetario e la Banca mondiale sembrano aver perso gran parte del loro potere.
C’è di più. C’è la diffusa sensazione che nemmeno gli strumenti della politica siano oggi più in grado di spegnere questi incendi e di riattivare un reale processo di sviluppo.
Il susseguirsi di guerre che sembravano concluse, ma nelle quali poi, come nel caso dell'Afghanistan e dell'Iraq, si riaccendono sempre nuovi focolai di tensione, il terrorismo che incombe dietro ogni angolo e l’apertura di nuovi fronti di crisi non lasciano per ora prevedere nulla di buono.
Lo spiraglio di luce che sembra essersi aperto, in Medio Oriente, per la soluzione del problema palestinese, è un segnale senza dubbio confortante.
Ma è troppo presto per dire se da questa striscia di terra potrà partire un più generale processo di pacificazione.
Lo scontro fra diversi e opposti progetti egemonici, in questo come in altri scacchieri del mondo, non ha, per ora, né vinti né vincitori.
Da qui l’alto grado di schizofrenia che caratterizza l’andamento dei mercati, costretti a vivere alla giornata e con una pistola puntata alla tempia.
Tutti i sistemi sono in difficoltà ma quelli che dispongono di minori difese immunitarie stanno pagando per questa crisi un prezzo più alto.
E’ il caso dell’economia italiana che, dopo aver seguito per anni rotte che prevedevano solo itinerari di crescita e approdi sicuri, ha finito con l’imballarsi.
Sta tentando, tra un fortunale e l’altro, una difficile navigazione a vista.
E bisogna dare atto al nostro Governo di aver fatto di tutto, in questi frangenti, per tenere almeno dritta la barra del timone.
Ma il fatto che non siano ancora in vista porti di sicuro approdo ha provocato, nel paese, un profondo stato di malessere.
La tendenza di famiglie ed imprese, difatti, sembra quella di restare chiuse nel proprio guscio in attesa di tempi migliori.
Ed è proprio questa mancanza di reattività un altro fattore di grande preoccupazione.
Poche energie in campo, molta voglia di tirare i remi in barca.
Credo che spetti, in primo luogo, alle Istituzioni, quelle con la I maiuscola, fare in maniera che questo diffuso malessere non diventi cronico e produca effetti ancora più perniciosi e di lunga durata.
Il che significa riuscire a dare, in tempi brevi, una più convincente risposta alle incertezze e alle insicurezze che stanno lievitando in Italia.
Da questo punto di vista il sistema delle Camere di commercio può essere un osservatorio privilegiato per il rapporto che ha con le realtà economiche e sociali.
Deve, quindi, diventare una stabile interfaccia con le imprese, soprattutto nella prospettiva della internazionalizzazione delle imprese e del sistema economico.
Il Paese deve avere interventi che, per essere efficaci, devono avere prima di tutto una forte valenza politica: occorre, da un lato, accelerare il cammino delle riforme ma, dall’altro, operare per eliminare i forti squilibri che esistono all'interno del sistema e che questa prolungata crisi sta aggravando.
E' molto importante che il Governo proceda nella realizzazione del suo programma di riforme. E, in questo senso, il suo fattivo impegno merita apprezzamento.
Sarebbe opportuno però che ci fossero, nella sua azione, meno effetti annuncio e più atti concreti. Meno uso di coloranti, più proteine e vitamina C.
Va aggiunto che non si può dire che le Istituzioni europee ci abbiano fino ad ora fornito adeguati supporti. Il tanto conclamato coordinamento delle politiche economiche ha, infatti, prodotto molto fumo e poco arrosto.
Essendo mancato, in Europa, un forte impegno di carattere politico, anche il Patto di stabilità comincia a mostrare le sue prime e consistenti crepe.
La verità è che si è costruita l’Europa pensando che bastasse controllare l’inflazione e i deficit e predisporre canali che consentissero una adeguata e diffusa irrigazione delle risorse.
Nessuno ha pensato all'eventualità che questi canali di irrigazione potessero restare a secco per mancanza di risorse. Così ha finito per bloccarsi il processo di sviluppo.
La costruzione di un’identità europea è certo un importante passo avanti, ma essa rischia di restare un ibrido, una cornice senza quadro, se non verranno predisposti gli strumenti che consentano una vera governance dell’Istituzione dell’Unione Europea.
Il progetto di Costituzione europea dovrebbe avere questo obiettivo, ma mi chiedo se esso, per come è stato disegnato e strutturato, potrà essere davvero funzionale alle esigenze del sistema.
Qualche dubbio ce l’ho e credo di non essere il solo ad averne.
E se questa Costituzione dovesse rivelarsi, alla prova dei fatti, solo una camera di compensazione tra i vari poteri ed interessi in gioco, il gap di competitività che già esiste fra l’Europa e gli Stati Uniti rischierebbe di assumere proporzioni ancora più vistose.
Non è chiaro, inoltre, quando e in quale misura i cittadini europei potranno attivamente partecipare alla costruzione di questa nuova realtà europea.
Il rischio, adombrato da Jean-Paul Fitoussi, che essi possano restare solo sudditi di un sia pur benevolo dittatore, mi sembra, allo stato delle cose, più che fondato.
La proposta avanzata dal ministro Tremonti di mettere subito mano, in Europa, ad un piano di investimenti nel campo delle grandi infrastrutture va sicuramente nella direzione giusta. E analoghi interventi andrebbero fatti nei settori dei servizi, della ricerca, della formazione e delle tecnologie avanzate.
In questi comparti non è stato fatto ancora quasi nulla e il rischio è di avere domani, per questo motivo, un’Europa a due, a tre o addirittura a quattro velocità. Un’Europa con i colori dell’Arlecchino.
E’ ora che Bruxelles la smetta di girarsi i pollici e metta mano a piani che le consentano di attrezzarsi per le competizioni future.
Perché una cosa deve essere ben chiara: senza creare importanti assi di scorrimento verso Est e verso il bacino del Mediterraneo, senza una vera politica dei servizi, senza ricerca, molti paesi europei e soprattutto l’Italia rischiano di perdere tutti i treni dello sviluppo.
Per questo ci auguriamo che il semestre a guida italiana serva a produrre qualche salutare scrollone: meno chiacchiere, meno giramento di pollici, più progetti operativi, mano finalmente alla politica.
Ed è questo il pressante appello che vogliamo, da questa tribuna, rivolgere al Presidente del Consiglio, Berlusconi: si metta subito al timone e porti a casa dei risultati. Di chiacchiere se ne sono fatte fin troppe.
Le prospettive della nostra economia, intanto, sono purtroppo quelle che sono.
Cioè preoccupanti, perché ormai siamo sul filo di una vera e propria stagnazione che potrebbe anche tradursi in qualcosa di peggio.
Un Pil che, a stento, potrà crescere, nel 2003, solo dello 0,5%, cioè al di sotto della media europea.
Dato che non rappresenta certamente una novità in quanto anche nell’ultimo triennio, a fronte di una crescita complessiva dell'UE del 5,8%, l’Italia ha avuto uno sviluppo di solo il 5,4%.
E poi una produzione industriale che resta in affanno e che, per quanto riguarda la competitività, continua a perdere colpi.
Per colpa della crisi mondiale certo, ma anche per cause più intrinseche e mai rimosse.
E ancora debito pubblico sempre a rischio per la costante lievitazione dei costi di gestione delle amministrazioni pubbliche. Al centro come in periferia.
Va dato comunque atto al Governo di aver evitato che questo debito si trasformasse in una voragine tale da compromettere il rispetto dei parametri imposti dal Patto di stabilità e le possibilità di sviluppo del nostro sistema.
Altre questioni restano sostanzialmente aperte.
Resta, infatti, in alto mare la riforma federalista sia perché non è stata ancora fatta chiarezza sui costi che potrà davvero comportare la sua attuazione sia per le forti divergenze che sembrano lievitare all’interno della maggioranza sulle sue modalità di impianto, di gestione e di funzionamento.
Su questo tema ritornerò più avanti ma una cosa va detta subito: il federalismo è certamente una riforma importante ma o essa risulterà davvero funzionale ad una reale modernizzazione di tutto il sistema economico o sarà meglio rimetterla sul banco e sottoporla ad un’attenta revisione.
E ancora: o essa servirà a diminuire i costi della macchina pubblica realizzando così quelle economie di scala indispensabili per un sostanziale abbassamento della pressione fiscale complessiva o sarà meglio su di essa riflettere e poi riflettere e poi ancora riflettere.
La forte e persistente caduta dei consumi, soprattutto nei settori dei beni durevoli e semi durevoli, è un altro elemento di grande preoccupazione.
Lo è per le imprese manifatturiere che oggi hanno magazzini colmi di merce che, anche a causa della crisi dell’export, non trovano più collocazione.
E lo è anche e in maggior misura per tutto il grande settore della distribuzione, oggi alle prese con introiti che si sono fortemente ridimensionati.
Ma lo è anche per l’Erario che, a causa della caduta dei consumi e del volume degli affari e degli scambi, ha dovuto rinunciare a parte di quelle risorse che sarebbero state necessarie per accelerare l’attuazione di una riforma che oggi, per il sistema, vale oro: quella fiscale.
Il miglioramento delle entrate tributarie, pari a quasi 12 miliardi di euro nei primi 5 mesi del 2003 (+10,7% sull’analogo periodo del 2002), è derivato, infatti, per circa il 70% da entrate di carattere straordinario (condoni e sanatorie).Se non ci fosse stata questa componente, le entrate sarebbero aumentate solo del 3,7%.
E poi risparmiatori che sono sull’orlo di una crisi di nervi perché non riescono più a trovare forme di investimento che siano sufficientemente remunerative.
Decine di miliardi di euro che, restando sotto il materasso, non vengono in alcun modo utilizzati per il rilancio della nostra economia.
E non posso non parlare, nel fare l’elenco dei principali fattori che determinano questa crisi, anche della politica del credito.
Ecco un’altra ingombrante anomalia del sistema!
Quella di una politica del credito che, invece di utilizzare gli strumenti che ha a sua disposizione per supportare i gangli di un sistema oggi tutto in difficoltà, sembra avere altre linee di indirizzo, altre priorità, altri orizzonti.
Le banche - ce lo ha ricordato di recente il Governatore della Banca d’Italia - continuano, nonostante la crisi, a godere di ottima salute, anzi, ad avere la pancia piena. Ed è un risultato lusinghiero.
Resta però il fatto che chi sta fuori delle banche - famiglie, operatori ed imprese - continua ad avere, invece, la pancia vuota e una salute che appare sempre più malferma.
Per fotografare questo evidente e stridente contrasto mi limito a qualche flash.
Nonostante l’ulteriore riduzione del tasso di sconto, decisa dalla BCE, portato ora al 2%, il credito finalizzato all’acquisto rateale può arrivare fino al 27,4% per acquisti di importo non elevato (1.500 euro) cioè sulla soglia di quello che viene considerato interesse usuraio.
Il costo dei servizi e delle intermediazioni bancarie resta abnorme e tutto a carico della clientela.
E non parliamo del costo del Pagobancomat tutto a carico dei commercianti.
L’ultimo esempio è dato dalla penale imposta dalle banche a chi non fornisce corrette coordinate bancarie.
E questo rappresenta un ulteriore e ingiustificato aggravio - 3,5 euro per ogni operazione - per imprese e famiglie.
Le piccole imprese continuano, inoltre, ad incontrare sensibili difficoltà nell’accesso al credito. E, quando alla fine lo ottengono, sono costrette a pagare tassi di interesse troppo elevati.
In altri paesi europei non è affatto così.
Un altro anello della crisi è quello della ricerca.
Qui siamo proprio all’anno zero perché, dai tempi in cui fu inventato il “moplen”, tutto o quasi tutto sembra essersi fermato.
Qualcosa è lievitato nel campo della medicina e della ricerca scientifica soprattutto grazie alla solidarietà dei cittadini, ma tutti gli altri settori sono rimasti a secco di idee, di progetti e di strumenti di sostentamento.
La ricerca universitaria è come se si fosse atrofizzata.
Si lavora solo su brevetti acquistati all’estero.
Siamo, da questo punto di vista, in fondo alla scala europea. Ed è anche questo fattore che contribuisce a ridurre e in misura sensibile la nostra competitività sui mercati mondiali oggi tornata agli standard degli anni sessanta.
Per scaramanzia preferisco non parlare di vero e proprio declino.
E' certo però che il sistema si trova oggi su uno scivolo assai ripido e, per questo, assai preoccupante.
Il Governo, non potendo più contare sulle risorse di un sistema che si è messo a produrre più debiti che ricavi, ha cercato di fare cassa in altri modi.
Cartolarizzazioni, qualche taglio di spesa ma fatto solo in punta di temperino, dato l’alto tasso di anelasticità dei costi della nostra Amministrazione Pubblica.
E poi un condono che, come ho già ricordato, sta dando un gettito assai più consistente del previsto.
Ci auguriamo che tutto ciò possa servire anche a ridurre l’entità della manovra che il Governo potrà essere costretto a fare con la prossima legge finanziaria.
Non è più certo il tempo per polemiche retrò, ma almeno una cosa lasciatemela dire.
Per recuperare risorse sarebbe stato meglio far leva su strumenti che consentissero prima di tutto un rilancio della domanda, anche perché essa sarebbe servita a far girare di nuovo un’economia oggi in fase di stallo.
E, invece di accelerare il programma di privatizzazioni, si è preferito vendere i gioielli di famiglia.
E se malauguratamente - ma facciamo tutti i debiti scongiuri - la ripresa, per cause ancora una volta indipendenti dalle nostre responsabilità, non arrivasse nemmeno nel 2004, con che cosa, finiti i gioielli e i condoni, si potranno rattoppare i buchi di bilancio?
Dato che il Governo sta approntando il nuovo documento di politica economica e finanziaria un altro rischio si profila all’orizzonte.
Il rischio è che le poche risorse oggi disponibili possano venire utilizzate non per mettere qualche nuovo mattone a quel nuovo modello economico di cui il paese ha sempre più bisogno, ma per tamponare ancora una volta le falle di quello vecchio e che, da molti punti di vista, mostra ormai la corda.
Detto in soldoni: o il Governo utilizzerà questa volta le risorse e gli strumenti che ha a disposizione per venire incontro alle sempre più pressanti esigenze di tutto quel sistema di imprese - distribuzione, servizi, turismo, trasporti - su cui oggi fa perno gran parte della nostra economia o sarà sempre più difficile programmare una politica di vero sviluppo di questo paese.
Il che vuol dire due cose.
Non limitarsi a fornire assistenza alla parte più malata del sistema ma creare anche forme valide di sostegno a quei settori di imprese che stanno, invece, continuando, nonostante tutto, a produrre valore aggiunto, investimenti e nuovi posti di lavoro.
E diciamolo una buona volta: sono settori che cominciano ad essere davvero stanchi, stufi, arcistufi di dover tirare la carretta da soli e comunque assai di più di quanto non vogliano o non sappiano fare altri.
E poi produrre regole, fissare procedure ma soprattutto attivare strumenti che siano destinati non solo alle grandi ma anche alle medie e alle piccole imprese che operano in ogni comparto e settore di attività.
Solo in questo modo potranno finalmente liberarsi, nel paese, nuove risorse e preziose energie.
Se no, il processo di riforme che questo Governo ha opportunamente avviato, rischia di finire su un binario morto.
Che il grande sistema che comprende le imprese della distribuzione, del turismo, dei trasporti e di tutti i servizi non di gestione pubblica sia oggi l'albero motore della nostra economia è un fatto che dovrebbe essere ormai acclarato.
Lo è da molti anni in tutti gli altri paesi nei confronti dei quali cerchiamo di essere competitivi.
Da noi, invece, continua ad essere una questione aperta perché, soprattutto a livello politico, non si è ancora riusciti a valutare la portata e le dimensioni del grande cambiamento intervenuto, in questi ultimi dieci anni, nel nostro sistema imprenditoriale.
E’ frutto di impreparazione, di miopia o di qualcos’altro?
Certe volte cadono le braccia perché si ha l’impressione di parlare con i sordi.
E siccome qualcuno potrebbe pensare che il mio ragionamento stia sopra le nuvole o pecchi di presunzione, credo che valga la pena di dare qualche dato.
Negli ultimi trent’anni, il peso nell'economia dell’industria manifatturiera si è ridotto sensibilmente: era del 40% nel 1970, del 38,5% nel 1980, del 32% nel 1990 e oggi supera di poco il 27%.
Al contrario, il peso sull’economia di tutto il sistema dei servizi di mercato, Pubblica Amministrazione esclusa, è cresciuto sensibilmente: pesava per il 36% nel 1970, per il 40% nel 1980, per il 45,4% nel 1990 e oggi supera il 51%.
Ed inoltre il trend di crescita annuo dell’industria è ormai solo dell’1,7%, la metà di quello registrato dal settore dei servizi.
Insomma è come se la piramide su cui si regge il sistema economico si fosse rovesciata.
Negare questa realtà vuol dire davvero tenere la testa dentro il sacco.
Ce ne vogliamo rendere finalmente conto?
La verità è che Fordismo e Taylorismo, i due modelli di organizzazione della produzione che hanno fatto la storia dell’industria, sono ormai, nel mondo, finiti in soffitta mentre il consumatore è diventato il centro del processo economico.
La centralità della fabbrica è sostituita dalla centralità dei servizi e ciò ha messo in crisi modelli che, fino a qualche tempo fa, sembravano insostituibili.
Ponendo al centro del sistema i consumi, la globalizzazione, con l'enorme bagaglio di tecnologie che si è portata dietro, ha profondamente cambiato lo stesso concetto di industria modificando tutti i suoi parametri di sviluppo.
Se oggi un prodotto viene importato dall'India ad un prezzo dieci volte inferiore a quello prodotto in Italia, per il consumatore finale non solo non c'è differenza ma c'è un sicuro vantaggio: spende di meno.
Solo che il prodotto indiano dà lavoro in India, fa parte del PIL indiano e non contribuisce, in alcun modo, al processo di sviluppo del settore industriale italiano.
Siamo insomma nel pieno di una società dei servizi sempre più dinamica e che non ha più confini, mentre quella industriale sta diventando sempre più rigida ed obsoleta.
Il che non vuole dire assumere una posizione che si ponga in antitesi con le esigenze del mondo industriale ma prendere coscienza degli effetti che la mondializzazione e l'innovazione tecnologica hanno prodotto e continuano sempre di più a produrre nella realtà economica.
Altri paesi, proprio perché da tempo si sono adeguati a questa nuova realtà, hanno potuto accrescere il grado della loro competitività.
In Italia, questo adeguamento, in gran parte, non c'è stato e ciò sta producendo assai negative conseguenze.
Di fatto, stiamo vivendo ancora nell'era dei dinosauri, nel mondo di Jurassic Park.
Ed è un fatto che davvero sconcerta.
E' ora di cambiare e Confcommercio farà di tutto per accelerare quello che ormai appare come un ineludibile processo di cambiamento.
La responsabilità individuale e collettiva ci deve portare a diventare tutti attori di un liberalismo democratico e di un nuovo, inedito modo di vedere il Welfare. Quello tradizionale aveva finito per deresponsabilizzare i cittadini.
Se vogliamo davvero una nuova società del benessere essa non potrà che fare perno, d'ora in avanti, sulla responsabilità del cittadino.
Il mondo politico continua ad avere ancora una percezione marginale di quel che comporta la costruzione di una vera società dei servizi.
Forse molti operatori della politica dovrebbero andare da un buon ottico e farsi misurare la vista.
E dovrebbero andarci presto. Subito, perché le imprese che operano per la realizzazione di questo progetto sono stanche di attendere risposte che non arrivano mai.
Sono imprese che, dal 1970 ad oggi, hanno prodotto l'85% dei nuovi posti di lavoro e alimentano ormai più del 51% del nostro prodotto lordo.
Chiaro o no?
Il fatto che siano ormai diventate il vero azionista di maggioranza di questo sistema non ha ancora purtroppo prodotto alcun significativo cambiamento nella conduzione della politica economica.
Ed è per questo che la loro pazienza è ormai agli sgoccioli.
L'esasperazione sta toccando punte estreme.
Tutto questo vuol dire fissare una diversa rotta dei piani di programmazione del nostro sistema economico.
Tutto questo vuol dire cominciare a convogliare le risorse verso quei settori che oggi mostrano maggiori e più concrete potenzialità di sviluppo.
E per sapere quali sono questi settori basta sfogliare i rapporti dell'Istat o quelli della Corte dei Conti.
Lì c'è, da tempo, già scritto tutto e con il maggior dettaglio possibile.
Si vuole davvero far ripartire - e sarebbe proprio ora - il settore della ricerca? Ebbene le risorse disponibili devono essere messe a disposizione anche di quelle imprese che mostrano oggi di averne maggiore necessità.
Si vuole finalmente dare un colpo d’ala al vetusto problema della formazione e della qualificazione professionale? Ebbene si convoglino risorse verso quei settori che, producendo veri posti di lavoro, hanno oggi bisogno di migliorare la qualità dell’offerta.
Si vuole dar corpo all’innovazione tecnologica? Ebbene si aiutino quei settori che, per far fronte alla sempre crescente e sempre più variegata domanda di servizi, hanno oggi l'esigenza di crescere dimensionalmente, cosa che la realizzazione di reti informatiche renderà certamente possibile.
Insomma deve finire il gioco delle tre carte per cui risorse, programmi ed investimenti vanno sempre da una parte e mai dall’altra.
E' finalmente chiaro questo concetto o no?
Il Governo cominci dunque a fare i propri conti.
Noi, da tempo, abbiamo già fatto i nostri.
Anche se ora ci sembrano esserci altre incognite.
Sull’arco politico della maggioranza stanno arrivando, infatti, nuove e non previste perturbazioni.
Speriamo che siano solo passeggere.
Perché se il tasso di litigiosità che sta caratterizzando il confronto anche all’interno dei partiti della maggioranza si mantenesse a livelli troppo elevati, anche i programmi del Governo potrebbero subire pericolose deviazioni o bruschi rallentamenti.
Senza una politica che sia fortemente coesa, non si va proprio da nessuna parte.
Questi non sono ovviamente affari nostri.
Ma rischiano di diventarlo se il livello di queste dispute finisse con lasciare la nostra economia in quella specie di stretto imbuto in cui oggi si trova.
E dentro questo imbuto ci sono proprio quei ritardi strutturali che impediscono la trasformazione della nostra società.
Il primo è quello della mancata riforma dell’Amministrazione Pubblica.
Ed è il caso di farsi quattro conti.
Nel 2002, le amministrazioni pubbliche hanno assorbito il 47,2% del nostro prodotto interno lordo, 590 miliardi di euro.
Con un dettaglio non trascurabile: 551 miliardi, cioè il 93%, sono serviti a coprire le sole spese correnti.
Spese correnti che sono, inoltre, passate dal 77,8% del 1999 all’80,8% del 2002. E sarebbero state maggiori se, nel frattempo, non fossero sensibilmente calati gli interessi passivi.
Nello stesso periodo le spese per investimenti sono, invece, diminuite dall’8,2% al 7,2%.
La spesa corrente della Pubblica Amministrazione continua cioè a drenare sempre maggiori risorse sottraendole agli investimenti.
L’esatto contrario di quel che dovrebbe accadere.
Si deve, si deve e ancora si deve avere il coraggio di cambiare rotta.
Basterebbe che si operasse uno spostamento di un solo 2% dalla spesa corrente a quella in conto capitale, per avere 10 miliardi di euro in più da destinare ogni anno a quegli investimenti di carattere strutturale che oggi servono a far crescere la società dei servizi.
E dove tagliare per poter recuperare questo 2% che farebbe, da solo, aumentare del 25% il volume delle risorse destinate ogni anno agli investimenti?
Vi sono settori come quelli dell'istruzione, della sanità e dei trasporti che, se recuperassero efficienza, potrebbero, a parità di prestazioni, costare assai meno di quanto costano oggi.
Naturalmente per raggiungere questo obiettivo non basta certo un intervento di semplice chirurgia plastica: occorre incidere in profondità e sul complesso della struttura liberandola da competenze che, in parte, andrebbero trasferite al settore privato.
E’ quel che altri paesi hanno già fatto da tempo e con ottimi risultati.
Noi no e continuiamo a chiederci il perché.
Altra riflessione. Il 40% della spesa corrente è oggi assorbita dalle prestazioni di carattere sociale ma i benefici che ne ricava la collettività sono insoddisfacenti.
E questo perché una parte di questa ingente spesa non arriva a destinazione ma si disperde in mille rivoli a causa della congestione e dell’inefficienza delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione Pubblica.
Tra la riforma federalista e questi problemi c’è una stretta correlazione.
Non basta definire, infatti, la mappa delle competenze ma bisogna agire in modo da evitare duplicazioni di funzioni e di spesa e di riprodurre sul territorio, quasi in fotocopia, un tipo di cultura amministrativa che si è rivelato troppo costoso e scarsamente funzionale alla crescita del sistema.
Senza interventi che consentano una sostanziale revisione dell’impianto amministrativo c’è il rischio che, aumentando le esigenze di cassa della finanza locale, possa anche lievitare e in misura considerevole la pressione fiscale complessiva.
Tutto il contrario di quel che il paese oggi si attende.
Abbiamo due patti di stabilità, quello europeo e quello interno. Bisogna fare finalmente chiarezza su entrambi.
Il primo deve essere certamente più flessibile per consentire politiche espansive.
Il secondo, invece, per funzionare, deve sciogliere due interrogativi: chi fa che cosa e chi tassa che cosa.
Quanto tempo dovremo ancora aspettare per avere una convincente risposta a questi due più che assillanti interrogativi?
Rappresentano, in questo senso, già un grosso campanello d’allarme gli aumenti delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali che molte amministrazioni hanno già realizzato per far fronte al decentramento di molte funzioni.
La riforma fiscale resta, intanto, ancora a mezz’aria perché non è chiaro quali potranno essere i suoi reali tempi di attuazione.
Sono ormai più di due anni che stiamo sotto la pensilina in attesa che passi il treno di questa riforma. E’ passato solo il primo, piccolo vagone.
E tutti gli altri quando arriveranno?
Anche sui contenuti di questa riforma che, nel suo complesso, va sicuramente incontro alle esigenze del sistema delle imprese e delle famiglie, ci sono alcune riflessioni da fare.
La prima riguarda l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
E’ giusto aver accorpato gli scaglioni in sole due aliquote, però resta da definire, e in ogni dettaglio, un sistema di deduzioni che, diventando più ampio e articolato di quello attuale, crei condizioni di equità per i redditi minori.
La seconda riguarda le imposte indirette.
Non avremo una vera riforma se essa non consentirà di abbattere - e sarà il caso di pensarci tutti insieme in Europa - anche le aliquote dell’Iva alleggerendo così il carico fiscale che oggi grava su settori strategici della nostra economia quale in primo, anzi in primissimo luogo, è, ad esempio, il turismo.
Lascia davvero trasecolati la miopia che fino ad oggi ha caratterizzato la politica nei confronti di questo settore.
Senza di esso, l’economia sarebbe oggi davvero con le pezze al sedere.
Ma si continua a pensare ad altro e a rimandare a domani e poi a dopodomani quel che già ieri e l’altro ieri avrebbe dovuto essere fatto.
Perché?
Altra riflessione. Qualcuno ci deve ancora spiegare quali forme di compensazione nel gettito verranno individuate per consentire alle Regioni di abolire l'IRAP, una tassa sicuramente iniqua e assurda perché colpisce proprio quelle imprese che oggi creano maggiore occupazione.
L'abolizione di questa tassa ci è stata promessa ma permettetemi di fare come San Tommaso: ci crederò, quando la vedrò.
Il gap infrastrutturale che sta pesando sul nostro sistema è ormai insostenibile.
Oggi, per dotazione di infrastrutture, siamo sotto la media europea per almeno il 15%, ma è solo una media perché i paesi maggiori e che sono con noi più direttamente concorrenti come Francia, Germania e Spagna, ci sopravanzano almeno del 30-35%.
La Spagna, nell’arco degli ultimi dieci anni, ha potenziato le sue infrastrutture di base del 31%. Noi, nello stesso arco di tempo, non siamo andati oltre il 9%.
Un ritardo impressionante e che non ha valide giustificazioni.
Le maggiori carenze sono nei settori della produzione dell’energia, degli acquedotti, delle comunicazioni, del sistema viario, ferroviario, portuale, marittimo e di tutti gli altri servizi di base.
Sono carenze, quelle della dotazione infrastrutturale, che riducono la competitività di tutte le imprese e di tutti i settori economici ma tagliano le gambe soprattutto al sistema dei servizi.
Queste carenze diventano poi, per il turismo, veri e propri macigni e, nel Mezzogiorno, si trasformano in voragini.
E' come se l'Italia disponesse di un enorme giacimento che però - e non si sa bene per quale ragione - ci si guarda bene dallo sfruttare.
A conti fatti, manca ancora, nel Mezzogiorno, almeno il 60% delle infrastrutture di base: solo il 23% delle linee ferroviarie è stato elettrificato mentre solo il 38% delle linee è oggi a doppio binario.
Sempre nel Mezzogiorno non solo manca il 36% degli acquedotti ma quelli esistenti, per inefficienza, disperdono almeno il 40% dell'acqua disponibile.
Se non si risolve davvero il problema del Sud - e le vecchie politiche meridionaliste certo non servono più - tutto il sistema-paese rischia di non poter riacquistare un sufficiente grado di competitività.
Una delle infrastrutture di base oggi più carente non solo al Sud ma in tutto il paese è quella dell'energia.
Su questo versante stiamo pagando il prezzo di incomprensibili e sciagurati errori e ritardi.
I black out che si sono verificati nei giorni scorsi e che sicuramente potranno ripetersi sono solo la punta di un iceberg di una crisi assai più profonda e complessa.
Mancano le centrali e manca anche una politica che possa realizzare e in tempi brevi, la necessaria diversificazione delle fonti di energia.
Da questo punto di vista l'Italia, rispetto all'Europa, è anni luce più indietro.
Il problema si presenta assai grave per vari motivi.
Primo, perché, in Italia, il costo dell'energia è del 30% superiore a quello della media degli altri paesi europei.
Secondo, perché gli interventi fino ad ora sono stati, in gran parte, finalizzati a ridurre i costi energetici di grandi imprese anche di matrice pubblica o ex pubblica, ma non quello delle piccole e medie imprese.
E questa è una sperequazione abnorme perché non si capisce il motivo per cui un bar, un ristorante, un albergo e tutte le altre strutture che devono fare fronte alle sempre più pressanti esigenze del consumatore debbano pagare bollette assai più salate di quelle che pagano altri.
E tra oneri, tasse, imposte e bollette questi comparti di impresa sono costretti a restituire mediamente allo Stato o alle Amministrazioni locali il 56,2% dei loro introiti.
Una follia.
E' positivo il fatto che sia finalmente decollata la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica.
E’ necessario, però, che sia attivata quanto prima la borsa elettrica e venga nuovamente prevista la figura dell'acquirente unico a tutela e garanzia degli utenti con bassi consumi.
Solo in un quadro di garanzie, infatti, gli operatori effettueranno gli investimenti in nuovi impianti necessari alla copertura della domanda elettrica del paese.
Ed è, inoltre, altrettanto urgente procedere a diversificare le fonti di approvvigionamento per ogni tipo di energia.
Non si sta operando con sufficiente energia né sul primo né sul secondo versante.
E che cosa racconteremo ai turisti quando gli alberghi resteranno senza luce e i ristoranti potranno offrire solo piatti freddi?
La riforma del mercato del lavoro era ed è un fatto ormai ineludibile.
Primo, perché l'aumento della flessibilità consente reali possibilità di sviluppo a tutto l’arco del sistema produttivo e della società dei servizi.
Secondo, perché offre finalmente anche alle piccole e medie imprese un più ampio ventaglio di opportunità per realizzare nuovi investimenti e per creare quindi anche nuovi posti di lavoro.
Non riduce insomma le garanzie dei lavoratori ma, rendendole più compatibili con le nuove esigenze del mercato, piuttosto le amplia e le consolida.
E il fatto che il referendum sull’estensione dei principi dell’articolo 18 alle imprese fino a 15 dipendenti non abbia avuto il consenso della grande maggioranza degli elettori è un’ulteriore conferma della giustezza di questa riforma.
Ma devo anche dire che sarebbe stato più opportuno non arrivare a questo referendum evitando così quelle lacerazioni che esso ha purtroppo prodotto nel tessuto sociale del paese.
E ciò sarebbe stato possibile se il confronto sull’altra riforma – quella sulle deroghe sperimentali dell’articolo 18 - fosse stato gestito con più lungimiranza e con maggiore equilibrio.
Lasciamoci pure questo problema alle spalle ma sarebbe preferibile non ripetere, in futuro, errori di questo genere.
Non illudiamoci però che, con il varo di queste riforme, tutto possa essere considerato risolto.
La riforma Biagi è un capitolo certamente importante della riforma del mercato del lavoro ma, perchè quest’ultima possa avere gli effetti desiderati, è indispensabile creare ammortizzatori sociali che consentano ad ogni tipo di impresa, qualunque sia la sua dimensione e il suo settore di attività, di poter fronteggiare i periodi di crisi con adeguati ed efficaci strumenti direttamente finalizzati al reinserimento occupazionale.
E' una grave lacuna del nostro ordinamento in materia di lavoro che va al più presto colmata e mi auguro che il Governo l'abbia ora ben presente e che si decida finalmente ad operare di conseguenza.
Attendiamo risposte a stretto giro di posta.
L'altra vera patata bollente del sistema è oggi rappresentata dal Welfare, un problema di grande entità che, del resto, oggi investe non solo l'Italia ma gran parte dei paesi europei.
Difatti, nel mondo, è solo l’Europa ad investire oggi oltre il 27% del proprio Pil nella sicurezza sociale.
L'obiettivo non può essere quello di sradicare questo diritto acquisito e che fa parte del Dna della cultura europea ma di cercare renderlo compatibile con le risorse del sistema.
Se in Italia abbiamo ormai il 25% della popolazione sopra i 60 anni, gli anziani, nella media europea, rappresentano il 22,4%.
Però, in Italia, le pensioni assorbono oggi il 65% della spesa sociale contro il 46,4% della media europea.
Con un'aggravante: mentre, in Europa, ci sono due giovani per ogni anziano, in Italia, a causa della pesante crisi demografica, il rapporto è ormai di uno ad uno.
Per questo, entro pochi anni, la situazione rischia di diventare per noi insostenibile.
Per uscirne non resta che, da un lato, allungare l’età pensionabile e ridurre il cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, dall’altro, far decollare la previdenza integrativa.
E’ sicuramente una riforma difficile da realizzare perché, incidendo profondamente nel tessuto sociale, potrà creare nuove e più complesse disarmonie nel sistema.
Ecco perché, prima di affrontare questa riforma, è indispensabile ricreare, nel paese, un clima che consenta un più sereno e costruttivo confronto fra Governo, forze politiche e parti sociali.
E ciò sarà difficile fino a quando pessimismo e frustrazione continueranno ad essere i convitati di pietra di ogni impresa e di ogni desco familiare.
E poi vanno riattivate fra Governo e parti sociali forme di concertazione che siano meglio strutturate e finalizzate agli scopi che vogliono raggiungere.
Una riflessione sul problema della giustizia.
Il sistema attuale non regge, non regge, non regge proprio più.
E il motivo è assai semplice: la società, avendo ormai cambiato, nel corso degli ultimi anni, pelle, tessuto e impianto, ha bisogno di poter contare su una macchina della giustizia che, per efficienza e produttività, sappia far fronte a sempre nuove, più pressanti e assai più variegate esigenze.
E' ormai di esasperante lentezza il processo civile, una lentezza che sta mettendo in seria difficoltà soprattutto quegli operatori economici che non possono sostenere la spesa di lunghi e sempre più costosi iter giudiziari.
Anche il processo penale mostra, nelle strutture e nelle stesse forme di gestione, vistose carenze e disarmonie.
E non mancano nemmeno le strumentalizzazioni.
E’ indispensabile quindi che tutto l’impianto giudiziario accelerando il suo processo di modernizzazione, a cominciare dalla riforma del codice di procedura civile, rafforzi almeno quattro dei suoi pilastri: l’efficienza, la rapidità nei giudizi, la certezza delle pene e un grado di autonomia che sia di garanzia per tutti i cittadini.
E non posso certo ignorare i contraccolpi che, sul sistema paese, continua ad avere una criminalità organizzata che, per forza e dimensioni, è oggi fra le più pericolose d’Europa, forse del mondo.
Non vi è dubbio che le attività di contrasto messe in opera dallo Stato in questi ultimi anni qualche positivo risultato lo abbiano conseguito.
Ma non si può certo dire che si sia arrestato il progressivo e sempre più invasivo inserimento di tali organizzazioni nel tessuto economico e sociale del paese.
Almeno un quarto del sistema delle piccole e medie imprese è costretto ogni giorno a fare i conti con questa drammatica realtà.
E diventano sempre più insostenibili i conti che bisogna fare con un abusivismo che continua a restare fuori da ogni controllo.
La criminalità urbana, la cui violenza sta crescendo in misura esponenziale, continua ad essere un vero allarme per il paese.
Devo dare atto al Governo di aver attivato più incisive forme di contrasto, ma purtroppo continuano ad accadere, anche a causa del cattivo funzionamento della giustizia e della sua incapacità di garantire almeno la certezza delle pene, fatti di eccezionale gravità.
Volete un macroscopico esempio?
L'assassino di Ezio Bartocci, il gioielliere ucciso nel 1999 durante una rapina nel suo negozio di via Padova a Milano, che, pure era stato condannato all’ergastolo, è stato rimesso in questi giorni in libertà a causa delle sue cattive condizioni di salute.
Nessuno intende ovviamente negare anche a questo assassino il diritto di essere curato, ma non si comprende proprio il motivo per cui questa assistenza non avrebbe potuto essere svolta da strutture che comunque impedissero a questo omicida di riacquistare la sua piena libertà.
Sono procedure inaccettabili in uno stato di diritto e che, invece, trovano purtroppo pratica assai diffusa se è vero, come è vero, che centinaia di criminali, pure condannati in flagranza di reato, ritornano presto liberi per poi commettere reati di ancora maggiore gravità.
Così non va, non va, non va.
Le famiglie di decine e decine di operatori commerciali uccisi solo perché avevano osato difendere la loro impresa non ne possono più di questa specie di giustizia che tutto è meno che vera giustizia.
Come occorre individuare strumenti più efficaci e di maggiore respiro per quanto riguarda il problema dell'immigrazione.
Va combattuta con energia e con adeguati ed efficaci strumenti quella clandestina ma, al tempo stesso, è indispensabile, come già fanno da tempo altri paesi europei, utilizzare anche questo strumento per potenziare una forza lavoro di cui questo paese ha crescente bisogno.
Quel che chiedono e in modo sempre più pressante le imprese che Confcommercio rappresenta e che sono ormai l’anima, il cuore e i polmoni di gran parte del sistema produttivo sono cose assai semplici ma tutt’altro che marginali.
Una politica di riforme che vada in profondità e punti ad una reale, profonda, trasformazione del sistema che faccia fronte alle esigenze di una società che, rispetto a dieci anni fa, ha ormai cambiato pelle, comportamenti, cultura e stili di vita.
Da qui alla fine della legislatura c'è tutto il tempo per realizzare questo obiettivo.
Ma bisogna cominciare a correre perché la meta è ancora lontana.
Occorre una politica che guardando in basso punti in alto, cioè crei le condizioni per lo sviluppo di un sistema che sia finalmente fondato sulla trasparenza e sull'equilibrio dei poteri.
Solo in questo modo si potranno creare i giusti presupposti per una reale democrazia economica.
E' un processo che richiama alla memoria quello che Platone ha descritto con il mito della caverna.
Costretti a vivere per lungo tempo dentro una profonda caverna gli uomini continuavano a pensare che le ombre proiettate sulle pareti e illuminate da un raggio di luce che filtrava dall'esterno fossero uomini e cose reali.
Solo quando poi riusciranno a mettere piede fuori della caverna comprenderanno che la realtà del mondo era, invece, cosa assai diversa da quella rappresentata da quelle ombre.
Ed è necessario - mi sembra il caso di ripeterlo e poi ancora di ripeterlo e poi ripeterlo all’infinito - che tutti finalmente si decidano ad uscire dalla caverna delle ombre e delle illusioni.
Perché l’unico modo per raddrizzare questa nostra barca è quello di guardare in faccia la realtà per quella che oggi veramente è sotto la luce del sole.
Il che vuol dire restituire credibilità a tutto l’impianto istituzionale. Ma non soltanto questo.
Abbassare il tasso di esasperata litigiosità che oggi sembra caratterizzare ogni tipo di confronto di carattere politico e sociale. E non soltanto questo.
Prendere decisioni e dar corpo a strumenti che consentano di liberare le tante e preziose risorse ed energie dell'economia dei servizi che oggi esistono, producono gran parte del valore aggiunto e dei nuovi posti di lavoro, ma che continuano inspiegabilmente ad essere ancora tenute sotto vetro, mortificate oltre misura, relegate addirittura in soffitta.
Come se altre forze, altre energie, altri sistemi di imprese fossero oggi in grado, da soli, di produrre vero sviluppo modernizzando l’impianto di questo paese.
Non è assolutamente vero, ma perché si continua ad agire come se, invece, fosse vero?
La scommessa di questa legislatura mi sembra che si regga anche su questa fondamentale premessa.
Il Governo tenga conto di questa realtà e cominci ad operare di conseguenza.