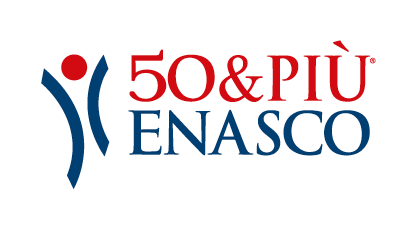La relazione di Sergio Billè all'Assemblea Generale di Confcommercio
La relazione di Sergio Billè all'Assemblea Generale di Confcommercio

Autorità, Signore, Signori, Signori Associati,
è il momento di guardarsi bene negli occhi e di dirsi la verità.
Togliamoci tutti la maschera e avremo fatto un passo avanti.
Smettiamola, smettiamola tutti con questo estenuante gioco del cerino.
La filosofia Zen impone di tenere pulito lo specchio in cui ci si guarda perché, se è sporco e polveroso, rischia di riflettere soprattutto ignoranza e cattiva coscienza.
Mi pare - questo - un buon metodo.
Per scuoterci ci serve una robusta dose di neorealismo alla De Sica.
Solo così potremo trovare la forza necessaria per far cambiare rotta ad un paese che ha innestato una pericolosa marcia indietro.
Tutti abbiamo una gran voglia di ripartire.
Ma non basta volerlo. Bisogna anche creare le condizioni perché ciò possa accadere.
C'è chi sostiene che oggi siamo più ricchi che poveri, tanto è vero - si dice - che le nostre strade sono sempre più ingorgate da schiere di auto in sosta in doppia, anzi tripla fila.
Ma è anche vero che le Amministrazioni locali spesso non riescono a trovare nemmeno i soldi per riuscire a rimuoverle.
Siamo sommersi dai cellulari.
E poi non è forse vero che gli utili delle compagnie di assicurazione sono cresciuti, nel 2004, del 43%?
Che le banche sono stracolme di depositi dei correntisti?
Che l'81% degli italiani vive già in una casa di sua proprietà?
Dietro questa facciata di floridezza, in parte vera, vive però un paese schiacciato da vecchi e da nuovi problemi.
Un esempio spicciolo.
Solo i sempre più frequenti intasamenti che si verificano nel nostro sistema dei trasporti ci costano ogni anno l'1,5% del Pil, 20 miliardi di euro.
E' difatti la grave carenza di infrastrutture e di logistica a farci perdere crescenti quote di competitività.
Ci pesano molte altre cose.
Da un'eternità, istituzioni e partiti disputano fra loro su come poter realizzare le grandi riforme necessarie per la modernizzazione del paese.
Ma è come se duellassero fermi su cavalli a dondolo.
Tutto viene continuamente messo in discussione, ma troppo poco si riesce a cambiare.
La maggior parte delle riforme di struttura restano crisalidi.
Non nego che questo immobilismo abbia molti padri e padrini.
Anche noi parti sociali – categorie di imprese e sindacati – abbiamo il nostro carico di responsabilità.
E non sarebbe male, dunque, che anche noi cominciassimo a fare un più serio esame di coscienza.
E' un paese in cui vige la regola che la colpa di tutto sia sempre di qualcun altro.
Dobbiamo smetterla di vivere in una sorta di grande "Circo Togni" dove ciascuno, dopo aver eseguito il suo numero, si ritira nella sua roulotte non preoccupandosi del resto.
A cosa serve rimpallarsi ogni mattina, e in ogni tipo di riunione, picchi e valenze strutturali della crisi che stiamo vivendo, se poi, arrivata sera, si spegne la luce senza aver pensato a qualche rimedio?
A cosa serve recitare a memoria, come tabelline della tavola pitagorica, le disastrose percentuali del nostro Pil, se poi non si riesce a fare nulla di serio per schiodarle dallo "zero virgola"?
Tirano le economie degli Stati Uniti, della Cina e di altri paesi del far-east asiatico, ma tira molto meno, invece, quella dell'Europa.
Sono ormai alcuni anni che si va avanti con questo copione.
Sono pesanti le responsabilità dell'Unione europea, come sono altrettanto pesanti quelle della politica, vecchia e nuova, di casa nostra.
Il paese segue i suoi acrobatici volteggi con crescente senso di frustrazione.
Sbagliano i partiti a sottovalutarne le possibili conseguenze.
Domani potrebbero aprire il cesto e trovarvi solo uova rotte.
E la domanda che tutti ci poniamo è: dopo le liturgie di un altro lungo anno di campagna elettorale, cosa accadrà, cosa potrà realmente cambiare?
Istituzioni, partiti e parti sociali non possono più restare adagiati sui loro sofà, mentre il paese corre il pericolo di essere sfrattato dall'economia mondiale.
Continuando così, amici, non ne usciamo.
Rischiamo di finire barellati in camera di rianimazione.
E' ormai nostro compito non dare più tregua alla politica e a chi opera nella stanza dei bottoni.
Dobbiamo star loro con il fiato sul collo.
Nel Governo e nei partiti che ne compongono la coalizione, c'è chi sostiene che il peggio sia quasi alle nostre spalle e che basterà qualche correttivo di rotta per uscire dal tunnel.
Anche un anno fa ci era stata detta la stessa cosa.
Poi i fatti hanno dimostrato il contrario.
Ecco, si dirà, il solito Billè che vede sempre la bottiglia mezza vuota e che agita le formulette del catastrofismo all'italiana.
Niente catastrofismo, ma il quadro è quello che è.
E cioè tortuoso, impervio, quasi spettrale.
Lasciatemi dire che, a questo punto, o si cambia tipo di approccio o si cambia.
Noi, per agevolare questo cambiamento, siamo disposti a fare tutti i passi necessari e penso che altre categorie di impresa dovrebbero essere disponibili a fare altrettanto.
Ma questo non servirà a nulla, se, nel contempo, le istituzioni e la politica non si decideranno a fare altrettanto e di più per affrontare i punti nodali di questa crisi.
Sono, difatti, molti i fondamentali che rischiano di sfaldarsi come creta: debito pubblico da collasso, rapporto deficit/Pil in via di crescente sforamento, produzione industriale più di là che di qua, domanda interna che pare il Mar Morto.
C'è l'impegno del Governo a cambiare questo stato di cose.
Ne prendiamo atto, ma ammetta, Signor Presidente del Consiglio, che per noi è difficile rimettere la mano sul fuoco, dopo che, come Muzio Scevola, ce ne siamo già bruciata una.
Ora, Signor Presidente, ci metta prima la sua. Poi, se tutto andrà per il meglio, come sinceramente ci auguriamo, non indugeremo a metterci quella che ci è rimasta.
Tra poco arriverà il momento della verità.
Perché o il nuovo Dpef e la nuova legge finanziaria saranno di straordinario impegno e fortemente innovativi per credibilità, indirizzo, spessore e qualità di interventi o la strada che ci aspetta è quella di una mulattiera.
La gravità della situazione impone - direbbe Max Weber - il prevalere nei partiti "dell'etica delle collegiali responsabilità". Mi pare, però, che oggi non ci sia proprio aria di intese bipartisan.
Intanto il tempo lavora contro di noi.
Per questo è indispensabile che la coalizione di Governo decida subito quel che intende fare.
Come sarebbe anche assai utile che l'opposizione cominciasse ad illustrarci quale programma alternativo intenderebbe realizzare per il rilancio dell'economia e per la modernizzazione del paese, nel caso in cui dovesse prendere le redini del Governo.
Per il momento, però, le idee sembrano un po' troppo in ordine sparso.
Non si comprende ancora bene cosa si vorrebbe cambiare, in quale direzione e con quali riforme.
Butto lì un'idea.
Non sarebbe il caso che l'opposizione mettesse in piedi una specie di Governo ombra, in grado di simulare i programmi che intende realizzare?
Intanto penso che sia arrivato il momento, per l'attuale maggioranza, di realizzare quel "governo della tenda", che gli Shogun apprestarono quando, in Giappone, si profilò la minaccia di un'invasione mongola.
Il che, a mio giudizio, significa fare scelte che siano anche durissime, anche impopolari, anche tali da provocare più di un serio mal di pancia, ma che - rispettando prima di tutto le esigenze e le priorità di un libero mercato - possano segnare una reale inversione di rotta.
Si possono anche chiedere sacrifici, ma è necessario che essi siano fortemente motivati, in maniera da dare al paese una reale prospettiva di sviluppo.
Troppi Gengis Khan ci tolgono oggi il sonno.
Alcuni li abbiamo già dentro casa.
Si chiamano sconquassata e costosa burocrazia, istituzioni scarsamente operative, politica molto ciarliera ma poco pragmatica, profonde dicotomie culturali, sociali ed economiche tra le varie aree del paese.
Nessuno di noi si illude che, di colpo, si possa risolvere tutto.
Però qualche brusca sterzata proprio ci vuole.
Altri Gengis Khan li abbiamo alle porte.
Si chiamano crisi di identità dell'Europa, un problema che - come certe bombe ad orologeria - ci ha messo del tempo prima di esplodere, ma poi, quando è esploso, ha fatto un gran botto.
Si chiamano, ancora, palesi incapacità di gestire una globalizzazione, che è divenuta sempre più esasperata e selvaggia.
Per affrontare questi Gengis Khan non basta rafforzare gli argini con qualche sacchetto di sabbia.
Così rischiamo di fare la fine del Polesine, quando il Po straripò a ponte Lagoscuro.
Può darsi – ma io mi auguro fortemente il contrario – che il destino di questa generazione sia, in parte, già segnato.
Dobbiamo batterci però, con le unghie e con i denti, per evitare che lo stesso destino tocchi alle nuove generazioni.
Non possiamo permetterci di consegnare ai giovani, a cominciare da quelli che da qui a qualche anno entreranno nel mondo del lavoro, un paese ancora taroccato e avvolto nelle nebbie dell'incertezza.
E smettiamola di dare sempre la colpa solo ai reggiseni, alle t-shirts e alle scarpe "made in China".
E' vero che incombe su di noi anche questo problema e che abbiamo fatto male, anzi malissimo, a prenderlo sotto gamba.
I nostri malanni sono però di assai più lunga data, tanto è vero che i loro sintomi erano già ben evidenti quando, nella Cina di Mao, si parlava ancora solo di libretti rossi e della banda dei quattro.
E mentre le istituzioni europee vivono la crisi forse più grave degli ultimi venti anni, noi che facciamo?
Pensa davvero la nostra politica che, per rimetterci in sesto, basti qualche partito in più o in meno?
Non nego che essa debba fare qualcosa di serio per migliorare la funzionalità del proprio impianto.
Bisogna fare, però, anche qualcos'altro.
Ma questo "altro" non emerge, non si materializza, non trova un'identità.
La delusione dei giovani si tocca con mano.
E' una delusione che rischia di produrre metastasi nel tessuto economico e sociale.
E noi che facciamo?
Vogliamo lasciare loro un grande paese con un piccolo debito pubblico o un grande debito pubblico in un sempre più piccolo paese?
Non possiamo sfuggire alle nostre responsabilità.
La crisi strutturale del paese sta facendo emergere contraddizioni sempre più profonde.
E' il caso di chiamarle per nome e cognome.
Guardiamo, ad esempio, al mondo del lavoro.
E' vero che il tasso di disoccupazione è sceso dal 9,1% del 2001 al 7,9% del primo trimestre 2005 ed è quindi ormai ai minimi storici.
Come è vero che questo è un dato in controtendenza rispetto alla media europea che, invece, lo ha visto salire, nello stesso periodo, dall'8,4 all'8,9%.
E' anche vero però che il nostro risultato sconta, in misura significativa, l'effetto della regolarizzazione dei lavoratori immigrati e del sommerso.
Un giovane su quattro non riesce, peraltro, a trovare ancora un impiego sul quale fare affidamento per poter programmare il proprio futuro.
Di costruirsi una famiglia, per molti giovani, nemmeno a parlarne, perché i soldi bastano appena per le spese accessorie.
Il 60% dei giovani trentenni non sposati resta con mamma e papà.
Il 35% dei giovani che perde un lavoro, deve aspettare, il più delle volte, almeno un anno per riuscire a trovarne un altro.
Il 50% del lavoro femminile resta confinato nella fascia delle mansioni meno retribuite e con minori prospettive di carriera.
I ricercatori, appena possono, fuggono all'estero come lepri.
Al Sud, ci sono laureati che, per pagarsi l'affitto, sbarcano il lunario con impieghi che, con le loro qualifiche, hanno davvero poco a che fare, mentre il 38% dei giovani che finiscono la scuola non sanno - in molte aree del Mezzogiorno - da quale parte guardare.
E sapete qual'è la novità?
Se, fino ad ieri, il problema del lavoro riguardava soprattutto il Mezzogiorno, ora anche al Nord, se prendesse piede la crisi del settore manifatturiero, potrebbero aprirsi, su questo versante, pesanti incognite.
La crisi che sta, ad esempio, colpendo il modello produttivo del Nord-Est potrebbe, in mancanza di efficaci rimedi, presto esplodere.
Tra mondo della scuola e mondo del lavoro, il rapporto resta difficile.
La riforma Moratti sta cercando di riannodare i fili di questo rapporto.
Solo dopo una sua reale sperimentazione, sapremo se essa potrà essere produttiva di risultati.
Il rapporto tra scuola e mondo del lavoro è un'equazione complessa e a più incognite.
Dalle università, ad esempio, esce ormai un esercito di laureati in scienze della comunicazione, ma un numero sempre più esiguo di ingegneri.
Diventeremo un paese di comunicatori, ma per comunicare che cosa – ha ragione, in questo, Romano Prodi – se, nel frattempo, si abbasserà ancora la soglia della ricerca e della formazione in materie scientifiche e tecnologiche?
Già oggi, soltanto il 27% dei nostri laureati consegue il titolo in queste materie, a fronte del 37% della Spagna, del 40% della Francia e del 47% di Finlandia e Svezia.
Mancano strutture e sollecitazioni che aiutino i giovani a fare scelte che servano a costruire un paese diverso e migliore.
Anche sul versante dell'offerta, del resto, c'è molta incertezza, perché molte imprese non sono più in grado di dire se - e in quale direzione - intendono programmare il loro futuro.
Molti giovani salgono in corsa sul primo autobus che passa, sperando che sia quello buono. Spesso, però, ne scendono fortemente delusi.
Il che non aiuta certamente la formazione di adeguate specializzazioni.
C'è chi sostiene che questo problema è legato al processo di liberalizzazione e di integrazione dei mercati, effetto rebound di quella "cultura della mobilità" che - in paesi come gli Stati Uniti - è diventata da tempo un valore intrinseco delle dinamiche di sviluppo.
Non scherziamo, per favore.
La mobilità può mettere legittime e virtuose radici dove c'è un sistema già strutturato e che sia capace di offrire - ogni giorno e in ogni direzione - non solo un grande e variegato ventaglio di opportunità, ma anche corsie preferenziali di specializzazione.
Noi viviamo ancora in un sistema talmente arretrato, sotto il profilo culturale e della valorizzazione del capitale umano, che i giovani spesso non trovano interlocutori con cui confrontarsi e che li possano adeguatamente motivare.
Certo, anche nel nostro mercato del lavoro qualcosa sta cambiando in positivo e sarebbe un errore sottovalutare gli sforzi che sono stati fatti.
La riforma Biagi - ad esempio - va sicuramente nella giusta direzione, anche se è probabile che essa avrà bisogno, in corso d'opera, di aggiustamenti e di correttivi.
Ma anche i sindacati devono cominciare a riflettere di più, perché un diverso approccio ai problemi del lavoro è ormai ineludibile.
Di flessibilità, infatti, il mondo del lavoro ha necessità. Ma affinché questa flessibilità non si trasformi in precarietà – ed anzi possa essere un'occasione per contrastarla – dobbiamo rapidamente portare a compimento e perfezionare quanto il Governo – e gliene va dato atto – ha fatto per riformare scuola e lavoro.
Mettendo poi mano ad altre attese riforme:
da quella che dovrebbe fare degli ammortizzatori sociali uno strumento efficace per il reinserimento occupazionale, ad una contrattazione che colleghi, in maniera più diretta ed efficace, l'andamento dei salari con quello della produttività.
Così come è ormai improcrastinabile il decollo della previdenza integrativa - l'altra faccia della riforma del sistema previdenziale pubblico - fondato sulla centralità del ruolo dei fondi contrattuali e sullo smobilizzo del Tfr.
Smobilizzo che deve, però, essere accompagnato da adeguate forme di compensazione degli oneri finanziari per le imprese.
Ma torniamo al quadro generale.
E' indubbio che il paese deve fare oggi i conti con una "matrioska" di problemi che, l'uno dentro l'altro, minacciano di togliere al sistema quote crescenti di competitività.
E' come se trasportassimo farina che, in gran parte, si perde per strada.
La mancata riforma delle istituzioni è diventata ormai un problema vistoso ed ingombrante.
Mi sembra grave che la nostra classe politica non sia riuscita, in diversi lustri, a gettare le basi di una riforma che, pur garantendo, come è ovvio, ogni tipo di controllo democratico, realizzasse un assetto dei pubblici poteri più funzionale alle esigenze di una moderna società.
Abbiamo messo insieme una Treccani di tentativi che o sono abortiti o rischiano di abortire.
Occorrono istituzioni che sappiano accompagnare i processi di sviluppo.
Vogliamo muoverci? Cosa aspettiamo ancora per muoverci?
E dentro questa "matrioska", sta anche la arretratezza della pubblica amministrazione, rimasta, in buona parte, improduttiva e appesantita da antiche rendite di posizione, che si sono talora addirittura aggravate.
"Riformicchie" ne sono state tentate parecchie, ma ogni volta è come tagliare un pezzetto di coda ad una lucertola.
Pochi giorni e la coda è già ricresciuta.
Si è rinnovato, quasi a peso d'oro, il contratto degli statali.
Per evitare una paralisi del sistema non si poteva forse fare altrimenti.
Ma si sta facendo ancora troppo poco sul versante della mobilità, mentre l'ingombro di funzioni e di scrivanie, producendo costi devastanti, continua a sottrarre importanti risorse alla parte più produttiva del paese.
Vi pare normale che il costo medio del lavoro per unità produttiva sia, nel settore pubblico, del 63% superiore a quello del privato?
Vi pare normale che lo Stato trovi i soldi per pagare gli stipendi, ma poi non trovi quelli necessari per saldare i conti dei propri fornitori, molti dei quali - nel comparto sanitario e dei servizi - devono attendere anche più di un anno per avere quel che a loro è dovuto?
E poi i ceppi di un'inconcludente burocrazia.
Un imprenditore italiano - che produce macchinari tessili e che ha appena impiantato un'azienda alla periferia di Shanghai - ha raccontato che gli sono bastati quaranta giorni, tutto compreso, per avere i nullaosta necessari per dar corso alla sua attività.
Dopo il varo del decreto per la competitività – impegno importante, anche se da solo non risolutivo, che il Governo ha onorato – abbiamo ora, in Italia, molte e nuove norme in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi.
Il problema è ora di vedere se e come potranno funzionare.
L'interrogativo difatti è: sapranno queste norme determinare una nuova cultura del servizio pubblico e, soprattutto, concorrere a realizzare rapporti più collaborativi tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese?
Le Camere di Commercio – per la loro natura istituzionale di "cerniera" tra l'iniziativa economica dei privati e il sistema delle regole pubbliche – potranno svolgere, anche in ragione del riconoscimento del loro ruolo nell'ambito del disegno di legge di riforma costituzionale, una funzione essenziale proprio per il perseguimento di questi obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di collaborazione tra pubblico e privato.
La macchina della giustizia continua – per parte sua – ad accumulare ritardi: non bastano otto anni per portare a termine un processo civile e ce ne vogliono almeno cinque – in sede penale – per passare dal primo al secondo grado.
Per quanto riguarda la riforma del diritto fallimentare, siamo solo ai principi della delega.
Anche qui, si tratta di vedere ora in che modo e con che tempi questi principi troveranno concreta attuazione.
Fino a quando i tribunali, per palese mancanza di strutture e di cancellieri, saranno sepolti da montagne di pratiche, servirà a poco modificare ruoli, funzioni e poteri dei magistrati.
Due riflessioni sul federalismo.
Esso è una suggestiva ed importante riforma, che però si regge ancora su una gamba sola.
Le manca l'altra: i settanta miliardi di euro necessari per realizzarla.
Per uno Stato - si dirà - che ha sulle spalle un debito di millequattrocentoquaranta miliardi di euro, cosa volete che siano settanta miliardi di euro?
Non scherziamo.
Settanta miliardi equivalgono a cinque punti di un Pil che, dal 2001 al 2004, è riuscito a crescere solo del 3,7%.
Si metta dunque in cantiere un vero schema di federalismo fiscale; si decida, prima di tutto, quale dovrà essere la diversa ripartizione tra Stato, Regioni ed Enti locali delle poche risorse pubbliche di cui il paese dispone, e poi si faccia tutto il resto.
Nella situazione attuale, il rischio è che, pressati dall'urgenza di reperire sempre maggiori risorse per finanziare i bilanci di Regioni ed Enti locali, si scateni la bagarre di un "fai da te" tributario, che vada fuori da ogni controllo e sia tutto a carico del mercato.
Produca, cioè, una nuova cascata di oneri e di tasse per famiglie e imprese, soprattutto nelle aree territoriali che si trovano oggi, per reddito e produttività, in condizioni più sfavorevoli.
Altra riflessione sul federalismo.
E' indispensabile che, nella legge di riforma costituzionale, sia riaffermato il principio che, nelle materie di esclusiva o concorrente competenza regionale, debba essere sempre salvaguardato anche l'interesse nazionale.
Insomma, sarebbe bene che le istituzioni decidessero quali sono oggi le vere priorità.
Prima l'uovo o la gallina?
Prima più massicci investimenti per innovazione e ricerca, per le infrastrutture e per la logistica o altre quinte di costosa burocrazia?
Le risposte dovrebbero essere quasi ovvie. Invece si continua a girare in tondo.
E' il momento, direbbe Leo Longanesi, di prendere la zappa e di ricominciare a coltivare il campo, prima che arrivi la carestia.
Siccome - però - potrebbe sembrare che io stia parlando dei problemi degli altri solo per cercare di nascondere quelli che, invece, il terziario si trova oggi in casa, mi pare opportuno cambiare spartito per affrontare le criticità del nostro sistema dei servizi.
A cominciare da quello che viene definito il suo "nanismo".
E' questa innanzitutto una definizione davvero troppo sommaria, perché non tiene conto del sempre più importante ruolo che medie e grandi imprese – nella distribuzione commerciale, nel turismo, nei trasporti – svolgono oggi all'interno dell'area dei servizi.
Insomma, nel nostro paese, il terziario non è né un sistema archeologico, né un sistema bloccato.
Comunque il Governatore ha ragione nel battere – e lo fa, del resto, da tempo - sull'eccessivo sottodimensionamento di molte delle imprese del terziario.
E' certamente uno dei temi da affrontare e da risolvere per realizzare una modernizzazione del sistema.
C'è da dire, però, che se non ci fossero stati questi "sette nani" a produrre, negli ultimi anni, una quota importante di lavoro e di ricchezza - mentre alcune Biancaneve pensavano magari solo ad annaffiare i fiori - il paese starebbe oggi assai peggio di come sta.
Basti pensare che le imprese sino a nove addetti producono oggi, nell'intera economia, il 34% del valore aggiunto e il 48% dell'occupazione.
E questo tipo di imprese, cioè i cosiddetti nani, producono, nel terziario di mercato, il 46% del valore aggiunto e il 58% dell'occupazione.
E' però vero che molti piccoli e medi imprenditori sono rimasti, per troppo tempo, refrattari al cambiamento.
Pur intuendo che qualcosa di importante stava accadendo, hanno spesso preferito, per incapacità o per scarsa attitudine al rischio o per altro, restare fermi in porto.
Ma faremmo bene a porci anche un'altra domanda: che cosa hanno fatto, di concreto e di programmato, la politica e i poteri pubblici - dallo Stato alle amministrazioni locali - per far uscire queste imprese in mare aperto, modernizzando le loro strutture?
Davvero poco. Troppo poco è stato fatto:
- sia per una rapida e più capillare informatizzazione delle reti pubbliche e per il loro dialogo con le reti private;
- sia per ridurre i costi dei servizi di base ed accessori, a partire da quello dell'energia;
- sia per realizzare processi di innovazione diffusa, rispondenti alle esigenze specifiche del terziario e delle PMI.
E troppo poco è stato ancora fatto per assicurare un più razionale e meno costoso sistema dei trasporti, extra ed infra-urbani, di merci e persone.
E, infine, per valorizzare, in modo più programmato, tutto l'impianto della nostra offerta turistica.
E cosa si è fatto e si sta facendo per le nostre città, cuore pulsante dell'economia e della società ?
I processi di ristrutturazione e di riqualificazione di molte delle loro aree rappresentano non solo una necessità inderogabile per cittadini e imprese che vi operano, ma anche una straordinaria occasione di incremento della ricchezza.
Ci rendiamo conto di quanta efficienza aggiuntiva si potrebbe realizzare nelle città – veri e propri distretti naturali del terziario e dell'innovazione – riqualificando centri storici e periferie?
Si parla da tempo di una legge-obiettivo. E' il momento di realizzarla, raccordando - intorno ad un progetto condiviso - investimenti pubblici e privati.
Anche le imprese di Confimmobiliare - aderenti a Confcommercio - rappresentano una grande risorsa per realizzare questo progetto.
E poi, parliamoci chiaro: questo nanismo è figlio anche di una cultura economica che, da ogni lato, è rimasta a formato ridotto.
La riprova sta nel fatto che le nostre aziende quotate in Borsa sono un quarto di quelle tedesche, un quinto di quelle francesi, un decimo di quelle giapponesi, un dodicesimo di quelle della Gran Bretagna.
E c'è anche il problema del credito.
Non nego che, negli ultimi anni, si sia fatto su questo versante qualche passo in avanti.
Ma è una fatica di Sisifo - per centinaia di migliaia di piccoli operatori che non sono in grado di offrire solide garanzie - convincere il sistema bancario di quanto potrebbe essere, nel medio periodo, redditizio investire nel settore dei servizi.
Il sistema del credito si sta svenando anche per cercare di tenere in piedi il settore manifatturiero.
Più che giusto, ma siamo proprio sicuri che lo sviluppo verrà ancora prevalentemente da questa parte?
Io qualche dubbio ce l'ho. E credo di non essere il solo.
E' indispensabile, inoltre, che le finalità imposte da Basilea 2, per quanto riguarda le modalità di erogazione del credito, tengano espressamente conto anche delle peculiari esigenze delle PMI.
Sarebbe infatti paradossale se, con l'adozione di nuove e più standardizzate metodologie di valutazione del rischio, venisse penalizzato, in termini di quantità finanziate o di costo del credito, proprio l'unico settore di imprese oggi in crescita in questo paese.
Nessuno con un po' di sale in zucca può oggi pensare che sia opportuno o legittimo gettare alle ortiche il patrimonio del nostro settore manifatturiero.
Non è questo il punto.
Il problema è quello di mettere insieme nuove idee e nuove strategie che, puntando su un suo radicale rinnovamento, possano farlo tornare ad essere competitivo sui mercati.
E' quello che stiamo facendo?
Ancora non mi pare. Mi pare che, invece di pensare a costruire diverse e più moderne strutture, ci si stia limitando a rinfrescare, con una mano di vernice, la vecchia facciata.
Voglio dire che se, a fine giostra, tutto o quasi tutto dovesse essere come prima, avremmo gettato dalla finestra altro tempo, molti soldi, molte energie ed anche molte speranze.
Per tornare ad essere competitivi sui mercati, molti dei nostri prodotti vanno sostanzialmente rimodulati e ripensati, e qualcuno anche dismesso.
Lo si sarebbe dovuto fare già da molto tempo, ma, per un complesso di motivi, non è stato fatto.
I contributi dello Stato non sono serviti a progettare un nuovo sistema industriale, ma, in gran parte, a garantire solo vecchie rendite di posizione.
Vogliamo parlarne o a toccare questo argomento si fa peccato mortale?
Sulle sole attività manifatturiere sono stati convogliati dallo Stato, tra il 1990 e il 2003, quarantotto miliardi di euro, cioè quasi 100 mila miliardi delle vecchie lire.
Ma nel frattempo - si dirà - cuneo fiscale e costo del lavoro hanno fiaccato ogni iniziativa di rinnovamento, nelle loro come anche nelle nostre imprese.
Le imprese tedesche hanno avuto più o meno gli stessi problemi, ma sono riuscite a restare leader in Europa nel settore dell'export.
Non ci sarà stato allora - per le imprese italiane - anche qualche difetto di manico?
Noi siamo pronti ad assecondare ogni tipo di iniziativa che possa servire a rilanciare nel comparto industriale ricerca e innovazione di impianti e di linee di prodotti.
Ma è ora di non giocare più partite truccate.
Se ne sono già giocate troppe.
Per questo, bene ha fatto il Governo ad affrontare la riforma del sistema degli incentivi alle imprese, senza lasciarsi incantare da tante e troppo interessate lodi della "488".
Come ha fatto bene a cominciare ad affrontare il problema della crescita dimensionale delle imprese.
Anche l'Unione europea deve fare però la sua parte.
Non mi pare che Blair abbia tutti i torti a sottolineare, ad esempio, l'incongruità di un'Unione, che ha destinato addirittura il 40% del suo budget al settore dell'agricoltura, pur rappresentando esso ormai solo il 2% degli occupati nell'eurozona.
Tra il 1990 ed il 2003, 36 miliardi e mezzo di euro - cioè il 58,1% del totale delle contribuzioni previste per l'Italia - sono finite nelle tasche della nostra agricoltura.
Mi chiedo, però: a fronte di queste erogazioni, quanti fondi sono stati, invece, destinati dall'Unione europea alla ricerca e alla sperimentazione, alla formazione, all'information technology e al potenziamento delle infrastrutture?
La cifra è talmente modesta che, nei bilanci dell'Unione, è finita tra le varie.
Uno "zero virgola qualcosa".
Così non va.
Parlando da europei, vorrei dire che questa Europa non ci sta proprio più di misura.
Ha prodotto, difatti, molti chilometri di normative, ma poco arrosto.
Del resto, per questa come per molte altre ragioni, è la stessa idea di Europa che viene messa in discussione, anzi rischia di essere rivoltata come un calzino.
Sarebbe folle pensare oggi di divorziare dall'euro.
E dove andremmo?
Argomento chiuso, perché ci resterebbero solo il Bosforo e i Dardanelli.
Questo non significa, però, non riflettere, di più e meglio di quanto non si sia fatto finora, sulla reale congruità e sulla valenza del grande disegno europeo.
Sergio Zavoli, nel commentare i risultati del referendum in Francia e in Olanda, si chiedeva, ad esempio, il motivo per cui la Costituzione degli Stati Uniti si apre con le parole "Noi il popolo …", mentre il progetto di Costituzione europea ha, al riguardo, un incipit assai più sfumato.
Credo sia anche questo il motivo per il quale si è decisa, nell'Unione, una opportuna pausa di riflessione.
La verità è che, anche per molti italiani, il matrimonio con l'Europa ha avuto lo stesso accidentato percorso di quei matrimoni che, una volta, si usavano fare per corrispondenza.
Scambi di foto ritoccate al bello, lettere piene di appassionate promesse, e poi…
Non basta discettare ogni giorno sempre e solo sui parametri di Maastricht.
Certo, se non ci avessero messo questa robusta catena al piede, chissà dove sarebbe oggi arrivato il nostro debito pubblico.
Però quali politiche economiche Bruxelles è riuscita ad attuare, in questi anni, per aiutarci a fronteggiare la crisi esplosa con gli attentati dell'11 settembre?
E' vero che senza lo scudo della moneta europea il vertiginoso aumento del costo del petrolio ci avrebbe mandato al tappeto.
E' anche vero, però, che - al riparo di questo scudo - siamo rimasti in mutande.
Le autorità di Bruxelles non possono più limitarsi, ex cathedra, a dare voti sulle pagelle.
Per coprire le spese del mantenimento dell'Unione e per far fronte ai suoi programmi, l'Italia - dal '90 ad oggi - ha sborsato più di 195 miliardi di euro, 380 mila miliardi delle vecchie lire.
In cambio, abbiamo avuto fino ad ora più crusca che farina.
E non provino a toglierci – questa è purtroppo l'aria che tira – altri otto miliardi di euro di fondi strutturali destinati soprattutto al Mezzogiorno, perché allora sì che potrebbe finire male.
E' importante che, oggi, le componenti della nostra politica facciano ogni sforzo per individuare una piattaforma comune, che consenta il rilancio di un'idea di Europa, che sia anche più rappresentativa dei nostri valori e delle nostre esigenze.
I partiti si dividano su altre cose, ma non su questo.
Scendo a valle, riprendendo il problema del terziario di mercato.
C'è chi guarda a quel che sta producendo l'esercito delle imprese del terziario con sufficienza, quasi con snobistico distacco.
Come per dire: non penseremo mica di consegnare le chiavi della nostra economia a questo popolo di nani, di osti e di bottegai, e poi di "supermercatari", trasportatori e immobiliaristi?
Chi dice queste cose deve aver fatto però poche letture, se non si è accorto dell'ormai inarrestabile processo di terziarizzazione che, proprio nei paesi più economicamente sviluppati, ha ormai mandato K.O. la vecchia cultura fordista.
Siamo seri.
Un conto è dire che la terziarizzazione del mercato va accompagnata da un incisivo processo di modernizzazione e di liberalizzazione di molti dei suoi comparti.
Un altro è pensare che questo processo si possa realizzare utilizzando soltanto le briciole di quella grande torta di risorse che, fino ad oggi, è stata destinata all'industria e alla spesa corrente dell'amministrazione pubblica.
Con un'aggravante.
Mentre in Francia, in Germania, in Gran Bretagna ed ora anche in Spagna, i servizi di mercato sono potuti crescere sullo zoccolo duro di imponenti investimenti nelle infrastrutture di base, da noi molto, troppo su questo versante resta ancora da fare.
Le cifre del gap infrastrutturale con i paesi che sono nostri diretti concorrenti sono impressionanti:
- meno 30% di logistica;
- meno 25% di reti di trasporto su gomma e su rotaia;
- meno 40% di informatizzazione del sistema;
- più 43% di costi accessori per le aziende a causa di tutte queste carenze.
Questo gap pesa drammaticamente sull'intero sistema produttivo.
Le imprese del terziario hanno, dunque, un doppio handicap: non ricevono aiuti, ma non possono nemmeno contare su valide infrastrutture.
Io butto lì una proposta.
Perché tutti i settori d'impresa non decidono, per qualche tempo, di rinunciare a qualsiasi forma di contributo statale, pretendendo però che, in cambio, queste risorse vengano destinate subito ad investimenti per infrastrutture?
Se questa iniziativa prendesse corpo, essa sarebbe un bel modo per fare davvero "squadra" fra le associazioni imprenditoriali.
Senza infrastrutture, avremo presto, infatti, un'industria bonsai, un sistema dei servizi bonsai e – quel che è peggio – anche un turismo bonsai.
La "bell'Italia" che tutto il mondo ci invidia rischia di diventare un investimento sempre più marginale per il turismo dei grandi numeri.
Senza infrastrutture, si muore, amici.
Non nascondiamoci sempre e solo dietro il dito dei veti ambientali e di legislazioni impossibili.
Vogliamo parlare dei tempi biblici che occorrono per realizzare una qualsiasi opera pubblica e della spirale dei costi che caratterizza ogni genere di appalti?
Vogliamo parlare della TAV - la mitica ferrovia a trasporto veloce – i cui costi sono passati dai 28 mila miliardi di lire, preventivati nel '93, ai 50 miliardi di euro, cioè 96 mila miliardi di vecchie lire di oggi? E siamo solo a metà dell'opera, perché mancano ancora sia l'asse per il Fréjus che quello per la sponda ligure.
Il resto della rete ferroviaria si sta ammodernando, ma ad altissimi costi.
Almeno, fossero serviti questi soldi a far funzionare meglio la rete dei collegamenti utilizzata ogni giorno dai pendolari.
Proviamo a chiederlo agli interessati.
Per il Mezzogiorno, mi limito a ricordare tre inderogabili priorità.
La prima è quella di una forte accelerazione degli investimenti nel settore delle infrastrutture. Se questo non avverrà, il Sud rischia di essere tagliato fuori dalle rotte del commercio globale e dallo sviluppo dell'area euromediterranea.
Ma si tratta anche di stabilire quale modello di sviluppo si vuole davvero realizzare in questa area.
Più industria e come?
Più terziario e come?
Il problema di fondo resta quello di fare scelte che finalmente valorizzino il grande patrimonio di risorse economiche, culturali ed ambientali di queste regioni.
Solo così si potrà rilanciare anche il turismo.
Infine, la criminalità. Se, fino a qualche tempo fa, la malavita organizzata era un nemico che insidiava dall'esterno il sistema, ora - a causa della crescente "legalizzazione" di molte delle sue attività - essa sta diventando parte quasi organica del tessuto economico e sociale.
Il che vuol dire che – per combattere questa criminalità con efficacia – lo Stato deve utilizzare strategie, strumenti e professionalità assai diversi dal passato.
Ecco - si dirà - il solito Billè che continua a menar il can per l'aia senza parlare mai di prezzi e di quel che è successo, in questi anni, nelle tasche degli italiani.
Senza ripetere cose già dette e ridette, vorrei fare solo alcune riflessioni.
La prima è che la moneta unica, per il modo in cui è stata introdotta, ha prodotto danni a tutto il mercato e non solo ai consumatori.
La verità è che, da parte delle autorità europee e italiane, è stato commesso il grave errore di non valutare, con sufficiente attenzione, le conseguenze che l'introduzione della moneta unica avrebbe provocato su un sistema economico dissestato come il nostro.
Per questo sarebbe stato anche opportuno mantenere una circolazione in parallelo di euro e lira per un assai più lungo periodo di tempo.
E così - dirà qualcuno - vi scaricate di tutte le responsabilità.
No. Perché non c'è dubbio che parte della produzione industriale e agricola e della distribuzione ha gestito male questo problema.
Ma dovremmo anche valutare, con maggiore attenzione, l'incidenza che – sui costi aziendali e, di conseguenza, sui prezzi – hanno avuto, in questa fase, l'aumento a raffica di tariffe, assicurazioni, banche, energia e affitti.
E ora rischiamo di essere da capo a dodici, a causa delle nuove impennate del costo del petrolio.
Io penso però che l'indagine che ora intende avviare su questo problema l'Antitrust, potrà - soprattutto se verrà, come sinceramente mi auguro, impostata nel giusto modo e con strumenti adeguati - ristabilire la verità dei fatti.
Noi, se ci verrà chiesta - e ci auguriamo che ci venga chiesta - daremo all'Antitrust la massima collaborazione.
Perché di concorrenza – e di più concorrenza – di liberalizzazioni – e di più liberalizzazioni – questo paese ha certamente bisogno.
Ma, contemporaneamente, occorrono regole e politiche che consentano alle imprese – a tutte le imprese – di crescere e confrontarsi sino in fondo con il mercato a parità di condizioni, quale che sia il settore in cui operano o la loro scala dimensionale.
Ho parlato poco di tasse. E l'ho fatto volutamente. Perché la mia impressione è che, ormai, paradossalmente più se ne parla, meno si fa.
E quel poco che si fa – soprattutto a ridosso del ciclo elettorale – si rischia di farlo male.
Del resto, i criteri per una necessaria riduzione della pressione fiscale, equa e virtuosa, sono a tutti noti:
- deve essere coperta da riduzioni della spesa pubblica corrente, perché è improponibile tanto il suo finanziamento in deficit, quanto la sua copertura attraverso spostamenti di quote del prelievo dall'una all'altra tipologia d'imposta;
- deve interessare tanto i redditi delle famiglie, quanto il prelievo a carico delle imprese, producendo effetti apprezzabili – si pensi alla vicenda dell'Irap – per tutte le imprese: per quelle esportatrici come per quelle che operano sul mercato interno, per le grandi come per le piccole.
Da qui alla prossima legge finanziaria, non c'è molto tempo. Ce ne è però a sufficienza per dare corso, con coerenza, a questi criteri.
Ivi compreso quello della lotta al sommerso e all'evasione.
La si faccia, finalmente.
Cosa aspettiamo ancora?
Le prospettive per la nostra economia sono purtroppo quelle che sono.
Primo, il Pil – quest'anno – anziché crescere, diminuirà dello 0,2%, rendendo così palpabile lo stato di recessione.
Secondo, gli investimenti pubblici e privati – rispetto al 2004 – diminuiranno dell'1,4%, mentre l'export calerà del 2,3%.
Si delinea un saldo della bilancia commerciale, che rischia di essere il peggiore dal 1991.
Terzo, i consumi delle famiglie aumenteranno solo dello 0,1%, cioè di quasi nulla.
E siccome, in queste condizioni, il rapporto deficit/Pil finirà con l'attestarsi sopra la soglia del 4%, si prospettano giorni duri, anzi durissimi per tutti.
Ma lasciatemi dire - è questa vuol essere la mia conclusione- che proprio non ci sto a considerare ineluttabili questi eventi.
Non siamo ancora morti.
Chi lo pensasse prenderebbe un abbaglio.
E questo perché abbiamo ancora, come il conte di Montecristo, ancora tutta l'inventiva e le energie necessarie per riuscire ad evadere dalla prigione dei nostri problemi e tornare ad essere "più vivi e più forti che pria".
Niente è perduto, se le Istituzioni e i partiti sapranno fare fino in fondo il loro dovere.
Niente è perduto, se imprese e sindacati, mettendo da parte egoismi corporativi, scenderanno in campo con più coraggio, con più decisione e con maggiore senso dello Stato.
E' un momento, insomma, nel quale la forza della ragione e l'etica delle responsabilità devono, in tutti, prevalere.
Quando, nel 1230 avanti Cristo, la provincia cinese di Lanzhou fu colpita da una terribile carestia, il mandarino chiamò a raccolta i cittadini. La mia ciotola, disse loro, è vuota come la vostra e a nulla ci serve riempirla di piagnistei cullandosi, nel frattempo, nella vana speranza che il riso possa domani cadere dal cielo. Ciascuno di noi si metta, anche a notte alta, a coltivare, invece, con più tenacia il proprio pezzetto di terra che non è stato invaso dalla piena del fiume e quel che ci occorre per sfamarci spunterà sotto i nostri piedi.
Appunto.
Cominciamo a coltivare e a far meglio fruttare le ricche e in gran parte ancora potenziali risorse di cui l'Italia dispone e la ciotola della nostra economia tornerà a riempirsi di tutto quel che ci serve non solo per sopravvivere oggi ma anche per programmare meglio il nostro futuro.