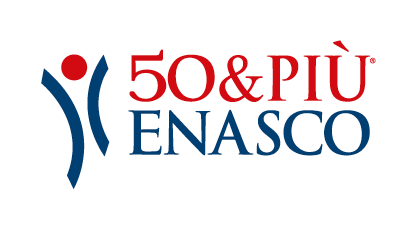La relazione di Sergio Billè all'Assemblea Generale di Confcommercio
La relazione di Sergio Billè all'Assemblea Generale di Confcommercio

Autorità, Signore, Signori, Signori Associati
dell’Italia di oggi si continuano a produrre immagini in grande quantità ma spesso assai diverse tra loro.
Ad ogni scatto di Polaroid, a seconda del punto di angolazione, corrisponde una diversa realtà.
E’ il paradosso di una società assai composita e stratificata che, da sempre, vive tra sogno e realtà, in un incessante moto pendolare tra due sponde estreme: troppo individualismo, da una parte, troppo conformismo, dall’altra.
La fotografia che ci convince di meno è quella che cerca di riprodurre l’immagine di un Paese vetusto, con i capelli bianchi, destinato ormai ad un inesorabile declino.
Non ci convince nemmeno l’immagine di un Paese sempre più opaco, privo di mordente, poco reattivo, rannicchiato su se stesso, quasi arreso, incapace di affrontare le dirompenti novità della società moderna.
Con un destino irrimediabilmente segnato, come quello degli anziani nel Giappone degli Shogun: assisi sul crinale della montagna a guardare l’orizzonte in attesa della fine.
Tutte queste sono immagini “truccate”.
Quello di “ritoccare” le foto è, del resto, un vizio che ci portiamo dietro da molti anni.
Grazie a Dio, siamo, invece, ancora vivi e vegeti. E con una grande voglia di fare e di crescere.
Lo siamo tutti. Lo è anche l’esercito dei nostri ultra-sessantenni.
Non pare però nemmeno convincente l’immagine di chi, al contrario, ci prospetta un Paese costantemente in marcia, capace di superare ogni tipo di ostacolo, strutturalmente proiettato verso il futuro.
Anche questo ottimismo sparso nell’aria con le bombolette spray ci lascia perplessi.
E quale sarebbe allora l’immagine autentica di questo Paese?
Quella, credo, di un Paese che ha una grande voglia di muoversi, ma che è costretto a restare in coda, spesso fermo, con tempi di sosta interminabili.
A causa di “cantieri” che si aprono e poi si richiudono e poi si riaprono e poi si richiudono. All’infinito.
E poi ci si meraviglia che possano esplodere, all’improvviso, forme di protesta come quella, ad esempio, degli abitanti di Montecorvino!
E’ questo, gira e rigira, il nostro vero problema.
So bene che parlando di questi “cantieri” tocco un “nervo scoperto”.
Un nervo che fa molto male.
Ma c’è un’Italia che è davvero stanca di stare in coda, chiusa dentro le sue minuscole scatole di latta, in attesa che questi cantieri finiscano i loro interminabili lavori.
Un’Italia stanca certo, ma niente affatto succube o “arresa” come dimostra anche la sua attiva partecipazione - doppia, in percentuale, rispetto a quella degli altri Paesi - al voto europeo ed amministrativo.
Voglia di partecipazione perché qualcosa cambi anche se, per ottenere finalmente questo cambiamento, non si sa più da quale parte guardare e a chi poter ancora dare fiducia.
E’ un’Italia che manifesta un crescente stato di incertezza e di malessere.
Insomma, un Paese “indispettito”.
Un Paese che si sente depauperato. Nel portafoglio e nelle aspettative.
I pressanti appelli che vengono lanciati alla politica perché abbassi il suo tasso di litigiosità e cominci a lavorare di più per il bene comune continuano purtroppo a cadere nel vuoto.
Una democrazia, per crescere, ha bisogno di istituzioni forti e di una politica che sappia produrre risultati.
Quando entrambe “si incartano”, rischia di “incartarsi” tutto il Paese.
Ne soffre anche l’economia. E parecchio.
E’ dalla caduta del muro di Berlino che si discute sulla necessità di una revisione del modello istituzionale che consenta una più efficiente e più moderna gestione di tutto l’arco dei pubblici poteri.
Il passaggio dal sistema di voto proporzionale a quello maggioritario avrebbe dovuto essere il primo segmento di un ben più lungo e significativo tracciato.
Ma, una volta che si è asfaltato questo primo tratto di strada, tutto si è bloccato di nuovo.
E il “fermo” del cantiere istituzionale continua a produrre danni.
Tutti, da ogni sponda politica, vorrebbero accelerarne i lavori ma poi non accade, di concreto, quasi nulla.
Nel frattempo il sistema rimane sostanzialmente “ingessato”.
Preoccupa, ad esempio, questo nostro bicameralismo elefantiaco:
- da un lato, gioca a domino con iter legislativi che, invece di semplificarsi, vengono “zavorrati” di continuo;
- dall’altro, fa il gioco dell’oca - un passo avanti e due indietro - con leggi come quella sulla tutela del risparmio che, in un sistema di moderna ed efficiente democrazia, avrebbero dovuto essere approvate all’istante.
E’ proprio il caso di dire: poveri risparmiatori!
Anche a causa di questo, il risparmio delle famiglie è stato in gran parte “dirottato”, nel corso dell’ultimo anno, sull’acquisto e la ristrutturazione di immobili o “parcheggiato” come liquidità.
E’ come se i risparmiatori si fossero barricati in casa.
Il Parlamento, pur avendo tutti i poteri necessari per sbloccare questa situazione, non ha saputo o potuto utilizzarli.
Brutta vicenda. Non la lava nemmeno l’oceano.
Dopo i casi dei bonds argentini, di Cirio e di Parmalat, dare una risposta efficace ed urgente alle esigenze di tutela del risparmio e di disciplina dei mercati finanziari resta una priorità cui una politica responsabile non si può sottrarre.
Restituire fiducia agli investitori e ai risparmiatori è, infatti, la premessa necessaria per creare, in Italia, mercati finanziari più efficienti e più trasparenti. Ricostruire questa fiducia è interesse comune di tutti gli attori del mercato creditizio e finanziario:
- dei cittadini per l’allocazione del loro risparmio;
- delle imprese per la loro provvista finanziaria;
- e anche, anzi soprattutto, delle aziende di credito.
Queste ultime devono ora dimostrare la capacità del modello di “banca universale” ad operare tanto sul terreno della consulenza ai risparmiatori, quanto su quello di una selezione del merito di credito che sappia accompagnare i processi di crescita delle imprese.
In particolare, di quell’impresa diffusa per la quale l’impatto degli accordi di Basilea si traduce in una preoccupante prospettiva di deterioramento di questo merito.
C’è molto da fare e, anche in questo caso, il tempo non è una variabile indipendente.
Bisogna affrontare – dopo la riforma del diritto societario – quella del diritto fallimentare.
Bisogna costruire quei fondi pensione di matrice contrattuale che possono contribuire al rafforzamento e alla trasparenza dei mercati finanziari.
Bisogna completare il processo di riforma e di rafforzamento dei consorzi di garanzia fidi.
E bisogna, ancora, che banca e impresa operino sulla stessa lunghezza d’onda, condividendo una cultura del finanziamento che privilegi gli strumenti partecipativi finalizzati alla crescita del capitale d’impresa.
Bisogna – rapidamente – varare le nuove regole per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
Regole cui spetta il compito – difficile, ma certamente possibile – di riequilibrare l’efficienza della governance societaria con la giusta tutela delle minoranze e di affrontare il nodo dei conflitti d’interesse tra partecipazioni rilevanti ed erogazione del credito.
Continuando con il gioco infinito delle “scatole cinesi” non si va più da nessuna parte.
Regole che sappiano rafforzare la vigilanza e l’investigazione finanziaria, ma anche la concorrenza nel sistema bancario e che, senza prefigurare alcun controllo politico del credito e della finanza, riconoscano però la necessità di doverose sedi di confronto e di verifica tra Autorità, Governo e Parlamento.
E, a questo punto, vorrei parlare anche dello strapotere che esercita, sul sistema economico, la nostra burocrazia.
Essa dovrebbe essere al servizio dei cittadini e del sistema di mercato.
Continua ad accadere, purtroppo, il contrario: sono i cittadini e le imprese ad essere prigionieri di un potere amministrativo che impone loro regole vessatorie e mortificanti anticamere.
Di tutto questo si sente parlare assai poco come se i veri problemi di questo Paese fossero altri.
Ma a vivere oggi tra le nuvole è chi non parla di queste cose e preferisce parlare d’altro.
In questi ultimi mesi, si è parlato, in tv, soprattutto di Iraq e di ostaggi.
Era giusto così e poi si trattava di argomenti che “tiravano” sugli ascolti.
Ma perché non parlare anche di chi, in Italia, continua ad essere “ostaggio” di un sistema che non funziona?
Perché mai un cenno o una parola, in tv, su tutte quelle imprese che, ogni giorno - nei settori della distribuzione, del turismo, dei servizi e dei trasporti - sono ostaggi su ogni tipo di problema che sia tassa, imposta, licenza, pratica amministrativa o altro?
Quando si farà finalmente qualcosa di concreto per la liberazione anche di questo “innumerevole” numero di ostaggi?
Continua ad esserci, ad esempio, un’odiosa, medievale tassa sulle insegne su cui lucrano ingiustamente le amministrazioni locali.
E io dico: attenzione, attenzione, amici.
Attenzione Istituzioni, classe politica ed anche mass media, perché la pentola dello scontento sta superando il punto di ebollizione.
Aprite bene gli occhi, tendete le orecchie perché l’elettore tende a comportarsi sempre di più come un’agenzia di “rating”: alza o abbassa il voto a seconda dei risultati che vengono raggiunti.
Del resto, questo è stato sempre un principio etico della democrazia e funziona.
Ovunque.
Anche le forme di reclutamento della nostra classe politica sono da sempre un problema.
Nel tracciare l’identikit dell’uomo che intenda esercitare la professione del politico, Max Weber indica nella passione, nel senso di responsabilità e nella lungimiranza le doti peculiari.
E ne aggiunge una quarta: poca vanità personale, molto spirito di servizio.
Non mi pare che si stiano sempre rispettando i canoni di Weber.
Né a destra né a sinistra.
E ad approfittarne è proprio la burocrazia che, arrogandosi un potere in qualche modo di “supplenza”, continua ad imporre i propri moduli di comportamento.
Weber aveva intuito anche questo sostenendo che “il peso crescente delle burocrazie è un dato strutturalmente pericoloso per la modernità della politica”.
Il concetto di “burocrazia”, in sé, non ha nulla di patologico.
Altrove, difatti, la burocrazia funziona.
E’, in Italia, invece, che ha assunto forme “patologiche”.
Essa ha, ad esempio, un costo del lavoro abnorme che è del 44% più elevato rispetto alla media di tutti i settori produttivi.
A prezzi costanti, un’unità di lavoro costa 783 euro al mese ai settori privati e 1.130 euro alla Pubblica Amministrazione.
Non è una lieve differenza.
Questo non è uno scalino. E’ uno “scalone”.
E siccome questi 1.130 euro li paghiamo tutti di tasca nostra c’è di che riflettere.
Tutto giustificato – lo scalone - dalla produttività e dal grado di efficienza della Pubblica Amministrazione?
A me non pare proprio.
Ma torniamo alla dirigenza politica.
Lasciamo pure perdere la “passione” che, in politica, è stato sempre un concetto assai “elastico”.
La cosa che spesso preoccupa è la sua mancanza di “lungimiranza”: dovrebbe adoperarsi di più per la costruzione di una società che punti allo sviluppo.
Ma è vero che la classe imprenditoriale dovrebbe sempre operare con maggiore “lungimiranza”.
Non è certo un problema che nasce oggi, ma è anche di oggi.
Anzi, oggi è attuale come non mai.
La somma di queste “patologie” che ci portiamo dietro da tempo sta aumentando il tasso di precarietà del Paese.
Cerco di descriverlo a volo radente.
E parto dal modo in cui lo Stato si è liberato del suo poderoso apparato industriale e finanziario.
Gli obiettivi di questa operazione avrebbero dovuto essere tre:
- primo: reperire risorse per fare investimenti nelle infrastrutture di base;
- secondo: contribuire al risanamento del debito pubblico;
- terzo: creare condizioni di un sistema di mercato che, rafforzando la libera concorrenza, creasse maggiori vantaggi per il cittadino.
Non sono stati compiutamente realizzati né il primo, né il secondo, né tanto meno il terzo obiettivo.
Alle “oligarchie” pubbliche si sono, difatti, sostituite quasi altrettante “oligarchie” private.
Monopoli erano e monopoli, in gran parte, sono rimasti.
Sono cambiate solo le targhette fuori della porta.
Cosa si è fatto per liberalizzare il settore dell’energia elettrica che, in Italia ha un costo che è del 25% - venticinque per cento, avete sentito bene - più alto di quello della media degli altri Paesi europei?
Anche il costo del gas è, in Italia, superiore del 30% alla media europea.
Nei giorni scorsi ha puntato il dito su questi problemi il presidente dell’Antitrust, Tesauro.
Una domanda però: non era compito di tutte le Authorities create in questi anni stimolare il processo di liberalizzazione del mercato?
E ancora – sulla “fragilità” del Paese - vogliamo parlare della carenza in molte aree del nostro territorio – meno 30% rispetto a Francia e Germania – della carenza delle infrastrutture e dei servizi di base?
O degli oneri che dai Comuni vengono “scaricati” sulle imprese per la raccolta dei rifiuti e che sono, per l’utenza, dell’80% più pesanti che negli altri Paesi?
Si ha un’idea di quanto questi fardelli pesino sulla gestione delle imprese e quanto essi, di fatto, riducano il livello della loro competitività?
La verità è che il nostro sistema corre oggi con una gamba sola.
Fino a quando il sistema dei servizi non potrà far leva su un’adeguata rete di infrastrutture non potrà puntare allo sviluppo.
Perché è inutile comprarsi un’auto se poi non ci sono strade su cui poterla utilizzare.
Occorre davvero un colpo di reni, necessario per alcuni precisi motivi.
Primo: la logistica, nel suo complesso, ha un costo, in Italia, mediamente superiore del 30-40 per cento a quella dei nostri principali concorrenti.
Secondo: i ritardi dovuti al semplice congestionamento dei trasporti incidono oggi per cifre che variano dai 20 ai 35 miliardi di euro, cioè dall’1,5 al 2% del nostro Pil.
Terzo: la privatizzazione delle grandi reti è stata fatta senza preoccuparsi della liberalizzazione del mercato, l’unica che avrebbe potuto garantire servizi di qualità e prezzi competitivi.
Quarto: gli investimenti infrastrutturali fino ad ora realizzati non consentono, per quanto riguarda i servizi su rotaia e l’integrazione via mare, alternative competitive al trasporto dei prodotti che rimangono pertanto affidati alla congestione del trasporto su gomma.
La somma di questi motivi rende praticamente impossibile, se non a costo di pesantissimi sacrifici, l’esercizio delle attività di servizio delle imprese del terziario.
Imprese che oggi rappresentano il 60% del prodotto interno lordo rispetto all’appena 35% di 15 anni or sono.
Far arrivare, ad esempio, nelle strutture commerciali, i prodotti da mettere in vendita ha oggi costi logistici e di trasporto che sono quasi doppi rispetto a quelli della media europea.
Tutto ciò produce effetti distorsivi anche sul sistema dei prezzi.
Ma queste “patologiche” carenze, al momento di pagare le tasse allo Stato e ai Comuni - Irpef, Irap e tanto, troppo d’altro - non sono tenute in alcuna considerazione.
Il motto della Pubblica Amministrazione è sempre uno e uno soltanto: “Solve et repete”, prima paga e poi qualcosa ti restituiremo.
E, aggiungo, forse.
Perché, ad esempio, non si può non citare, nel lungo elenco delle cose che non vanno, anche la lentezza con cui vengono eseguite le grandi opere pubbliche.
Con la legge obiettivo qualcosa sta cambiando, e di questo bisogna sicuramente dare atto a questo Governo.
Il tempo medio che, però, è stato fino ad ora necessario, in Italia, per realizzare un nuovo asse infrastrutturale è di 14 anni e mezzo contro i 4 e mezzo della Spagna, i 5 della Germania e i 6 e mezzo della Francia.
Non bisogna essere premi Nobel per capire che tempi così lunghi di realizzazione comportano non solo costi assai più elevati con conseguente sfondamento dei piani di spesa, ma anche un allestimento di opere che rischiano di essere realizzate solo quando sono ormai “datate” e quindi parzialmente improduttive.
Un esempio. La realizzazione della TAV, il trasporto su ferrovia ad alta velocità, aveva, quando fu progettata nel ’93, un piano di spesa di 28 mila miliardi di vecchie lire di cui solo il 40% a carico dello Stato.
Una volta entrata in funzione, questa spesa avrebbe dovuto essere ammortizzata in 16 anni con un prezzo del biglietto per il trasporto del 20% inferiore a quello aereo.
Oggi il costo di quest’opera che, nel frattempo, è finito interamente sulle spalle dello Stato, non è inferiore a 80 mila miliardi delle vecchie lire.
E forse non basteranno perché parte delle tratte della TAV non entreranno in funzione prima del 2010.
Certo, pesano i “vincoli ambientali”.
Ma parlando di questi vincoli dovremmo cominciare a chiamare le cose con il loro vero nome.
Perché il primo, vero “vincolo ambientale” è rappresentato dall’estrema farraginosità della nostra burocrazia e delle leggi che la governano.
Chilometri e chilometri non di strade, ma di norme e di regolamenti assai spesso in contrasto tra loro.
Progetti, strategie ed opere, a causa di tutto questo, continuano a restare a mezz’aria.
E’ compito del Governo e della politica intervenire perché ci sia una sostanziale correzione di tiro.
Come continua a fare “scandalo” – non c’è altro termine più appropriato - l’inadeguatezza - abissale al Sud - di reti metropolitane, di trasporti pubblici di superficie, di acquedotti, di fognature, di sistemi elettrici, di impianti per lo smaltimento e la trasformazione dei rifiuti, di infrastrutture per lo sviluppo del turismo e dell’intrattenimento.
Di sviluppo del Mezzogiorno si continuerà a parlare solo in astratto fino a quando non si risolveranno soprattutto questi problemi.
Soprattutto, ma non solo.
Perché l’agenda per il Mezzogiorno continua ad annoverare una fitta serie di questioni aperte: lotta alla criminalità e impegno per la tutela della legalità; fiscalità di vantaggio; valorizzazione dei “giacimenti” dei beni culturali ed ambientali.
Che noia, si dirà, ripetere sempre le stesse cose.
Che scandalo, dico io, trovarseli sempre di fronte e dover continuare a convivere con essi!
Proseguo nel volo radente.
Ci viene, ad esempio, da sorridere di fronte alla proposta di “importare” in Italia l’idea del Ministro francese Sarkozy per una riduzione dei prezzi da parte della distribuzione.
Sarà bene, a questo proposito, chiarirsi le idee.
Prima si “importi” in Italia anche l’efficienza delle infrastrutture e della pubblica amministrazione della Francia e, poi, si potrà discutere anche di questo.
Prima si cancellino tutti i costi aggiuntivi che le imprese della distribuzione sono costrette a sopportare ogni giorno per l’inefficienza del sistema e, poi, parleremo volentieri anche del resto.
Noi siamo disponibili insomma ad affrontare il problema dei prezzi sempre che, su di essi, ci sia finalmente un approccio serio e che parta da logiche strutturali.
Un approccio, in altri termini, che riconosca il valore del pluralismo distributivo italiano.
Un pluralismo di gruppi e di formati dimensionali, che merita scelte per il rafforzamento della sua efficienza.
Scelte per preservare un tessuto unitario di regole di mercato anche nell’Italia del federalismo commerciale.
Scelte per mobilitare strumenti e risorse della politica economica: a cominciare dai processi di riqualificazione delle aree urbane per finire alla formazione e all’assistenza tecnica.
Oggi i cittadini e le imprese pagano, in Italia, troppo allo Stato ricevendo troppo poco in cambio.
La “cura da cavallo”, cui il Paese è stato sottoposto per l’adesione al Trattato di Maastricht, con tutto quello che ciò ha comportato, compresa la “conquista” dell’euro, avrebbe dovuto essere accompagnata anche da pesanti tagli a tutti i gangli costosi ed improduttivi della spesa pubblica.
Ma, fino ad adesso, su questo versante è stato fatto assai poco.
A pagare “dazio” - e che dazio, amici! - per questa adesione sono state interamente le nostre famiglie, da una parte, e le nostre imprese, dall’altra.
Credo però che per meglio fotografare i ritardi che si sono accumulati in questi anni nel processo di ammodernamento del Paese, un altro esempio sia necessario.
Nonostante che segnali di perdita di competitività affiorassero, nel nostro sistema economico, ormai da tempo, poco o nulla è stato fatto da parte dello Stato per fare investimenti nei settori della ricerca, delle tecnologie e della formazione.
Eppure la traumatica scomparsa di settori chiave come quelli dell’informatica e della chimica avrebbe dovuto essere qualcosa di più di un campanello d’allarme.
Anche nelle università, ricerca e innovazione hanno messo le ragnatele.
I ricercatori, con una lenta ma efficace operazione di mobbing (“non ci sono soldi per voi!”) sono stati invogliati a fare le valigie.
Ora si cerca, in qualche maniera, di recuperare ma, intanto, sono stati persi più di 15 anni.
Dobbiamo dunque accelerare e rafforzare l’impegno per tutte le azioni finalizzate alla qualificazione delle risorse umane: per l’Università e la ricerca, per la scuola e per i percorsi di alternanza tra scuola e lavoro, per la formazione continua.
Genova, ad esempio, con il progetto dell’Istituto Italiano di Tecnologia, dimostra che fare di più per recuperare il tempo perduto è possibile.
In più, lo Stato ha continuato ad operare con la sua vecchia ottica convogliando su quel che restava delle partecipazioni statali e sugli altri comparti industriali una grande quantità di incentivi che però, per la maggior parte, sono stati assegnati, come dire, “in bianco”.
Senza la clausola cioè che essi dovessero servire a potenziare prima di tutto la ricerca, l’ammodernamento tecnologico delle strutture, lo sviluppo dell’occupazione e la competitività.
Così ci troviamo di fronte ad una compagnia di bandiera, l’Alitalia che, nonostante abbia ingoiato, in questi anni, enormi quantità di risorse, non ha fatto ancora nulla di concreto per ristrutturarsi e tornare ad essere competitiva in un settore certamente strategico come è quello del trasporto aereo.
Vi sono stati sprechi inauditi. In tutti i sensi, in tutte le direzioni.
E chi sta pagando tutto questo se non noi?
Per quanto riguarda il Mezzogiorno, questa politica degli incentivi ha fino ad ora prodotto lo stesso risultato che può produrre un’autobotte che versa acqua nel deserto.
Gli incentivi ai settori privati vanno rimeditati e rimodulati.
Vogliamo parlarne o anche questo argomento deve essere considerato tabù? Vogliamo parlare del fatto che i 24 miliardi e mezzo di euro stanziati negli ultimi due anni sotto forma di incentivi alle imprese del Mezzogiorno non hanno garantito sufficienti ritorni né in termini di nuova occupazione né di aumento del Pil e che vi sono 15 miliardi di euro di “residui” cioè di somme non utilizzate, anche per interventi di tipo infrastrutturale?
Parliamone perché così non va.
E’ tutto il meccanismo degli incentivi che va rivisto e ripensato.
A dimostrazione di ciò bastano tre esempi.
Primo, il credito di imposta è andato a beneficio di aziende che, per almeno il 50%, non ne avevano diritto. Altre che ne avevano diritto sono state, invece, escluse.
Secondo, i cosiddetti “contratti di programma” non sono decollati, tanto è vero che, dal 1996 al 2003, risulta erogato solo il 37% delle somme che sono state stanziate.
Terzo, il sistema degli interventi a pioggia previsto dalla legge 488 ha avuto effetti occupazionali per lo meno dubbi e non rispondenti ad una logica di strategia economica.
Nessuno di noi è così scriteriato da pensare che questo Paese possa risolvere i suoi problemi penalizzando, in qualche modo, il comparto industriale.
Io penso esattamente il contrario.
Ma la benzina va messa nei serbatoi per far correre le macchine e non per continuare a far girare il loro motore in folle.
Si attui, per gli incentivi, una produttiva correzione di tiro e a beneficiarne sarà, in primo luogo, l’impresa manifatturiera.
Sarà questo uno dei tanti argomenti “caldi” del nuovo documento di programmazione economica e finanziaria.
La speranza è che, sulla spinta di nuovi, diversi e più strutturati moduli strategici, tutta l’economia possa finalmente ripartire.
Sarà così?
Non voglio perdere l’ottimismo, ma, come San Tommaso, crederò quando vedrò e potrò toccare con mano.
E’ importante la decisione del nuovo Presidente di Confindustria - al quale rinnoviamo i migliori auguri di buon lavoro - di voltare pagina.
E accettiamo di buon grado l’invito che anche a noi egli ha rivolto di sederci intorno ad un tavolo per avviare forme di confronto fra tutte le parti sociali, che possano essere più produttive di risultati: sia sul versante delle iniziative contingenti, sia su quelle di maggiore valenza strategica.
Il che vuol dire ricominciare a parlare davvero – ma a 360 gradi - di imprese, di occupazione, di riforme e di mercato cercando, per ciascuno di questi grandi temi, vere soluzioni.
Ed è importante che siedano a questo tavolo i sindacati dei lavoratori perché, senza un loro sostanziale e costruttivo apporto, questo Paese rischia di non “svoltare”, di non andare da nessuna parte.
Ma, se vogliamo fare finalmente “centro”, in questa stagione di confronto dobbiamo mettere tutti sul piatto qualcosa di nuovo e di diverso.
Anche dai sindacati ci attendiamo qualcosa di nuovo e di diverso.
Qualche “sì” in più e qualche “no” in meno.
Anche quando si negoziano i contratti, anche quando si parla di flessibilità del mercato del lavoro.
E noi puntiamo – sia ben chiaro – ad un tipo di flessibilità che sia contrattata tra le parti e che, anche per questo, non diventi mai precarietà.
Lo abbiamo dimostrato con una posizione chiara, quando si è posto in discussione il problema di una riforma dell’art. 18.
Questa è la nostra “cultura”. E non intendiamo cambiarla.
Ma i sindacati devono rendersi conto che viviamo ormai in una realtà economica, nella quale anche la flessibilità è diventata un dato strutturale.
Comportarsi come se questo dato non esistesse è impossibile.
Per questo noi crediamo che alla trattativa non ci siano alternative.
Individuare un “metodo” che consenta l’avvio di una nuova stagione del dialogo è assai importante.
Che si chiami concertazione o in altro modo poco importa.
L’importante è smetterla di parlarsi solo per posta o utilizzando la sponda e i “filtri” dei mass media.
E’ quello che, fino ad adesso, è troppo spesso accaduto.
E a trarne vantaggio sono state proprio quelle forze che, per poter continuare a gestire, nel solito modo, le loro leve e le loro rendite di potere, hanno sempre avuto bisogno di un sistema che restasse il più possibile frammentato e conflittuale.
Perché questo dialogo possa funzionare, le parti sociali devono rafforzare anche il loro “status” di soggetti politici autonomi.
Lo si sta facendo. Ed è anche questo positivo.
E’ proprio partendo da queste basi che il confronto con la politica e con il Governo potrà diventare più produttivo di risultati.
Nessuna forza politica, a qualunque schieramento essa appartenga, può ormai sottrarsi a questo confronto.
Il Governo ha di fronte una fitta agenda di scadenze e di problemi.
Tra questi problemi, anche quello di riforme che restano, per così dire, “appese” perché su di esse non si riesce a trovare un accordo nella maggioranza.
Il desiderio di noi tutti, quello di contribuire a far fare al Governo le cose che servono per uscire da questa lunga fase di stagnazione, è fuori discussione.
Siamo in presenza di un’economia internazionale che continua a dare purtroppo segnali incerti e ondivaghi.
USA, Cina e Giappone in crescita, ma non si sa per quanto tempo. L’ Europa, invece, sempre sotto sforzo.
Oltre ai fattori della geopolitica - le pesanti incognite che ancora riserva la situazione in Iraq e in tutto lo scacchiere medio-orientale - sussistono altri pesanti elementi di incertezza:
- il probabile aumento dei tassi di interesse da parte della Fed;
- la miccia a lenta combustione del prezzo del petrolio, con gli effetti che esso potrà generare sul processo inflazionistico e sugli oneri del debito pubblico;
- gli equilibri della finanza pubblica oggi in via di peggioramento, sia negli USA come in Europa.
Si stanno accumulando debiti pubblici che, un giorno o l’altro, gli Stati dovranno pagare.
E’ evidente che l’Italia, proprio perché non può subire passivamente gli effetti di questo ciclo internazionale, deve approntare una politica economica rigorosa, ma anche lungimirante, attraverso misure - sia di tipo congiunturale sia di carattere strutturale - “focalizzate” sul rilancio del mercato interno.
Secondo le stime del nostro Centro Studi, l’aumento del PIL, nel 2004, resterà ancorato all’1,1%. Così siamo sul filo del rasoio.
Anche nel 2005, rischiamo di restare al di sotto della media europea.
Preoccupano inoltre sia la debole crescita dei consumi delle famiglie – solo +1,2% nel 2004, poco più dell’1,5% nel 2005 – sia il troppo debole recupero degli investimenti (+2,4% nel 2004, + 3,2% nel 2005).
Sull’inflazione continuano a gravare molte incognite.
Soprattutto quelle del prezzo del petrolio e del rapporto di cambio euro-dollaro.
E, infine, le persistenti difficoltà della finanza pubblica con un rapporto deficit/Pil che - se non si porrà mano a una manovra correttiva - rischia di superare la soglia del 3,3% nel 2004 e del 3,9% nel 2005.
E’ il Governo a doverci dire quali dovranno essere i contenuti di questa manovra.
Come appare ineludibile una riforma che consenta di correggere, nel medio periodo, la curva della spesa pensionistica.
L’Ecofin, su questo versante, ci sta col fiato sul collo e così pure le agenzie di “rating”.
E’ una situazione che, sulla carta, appare difficilmente coniugabile con gli obiettivi di riduzione della pressione fiscale, a meno di drastici interventi per il contenimento della spesa pubblica corrente.
Siamo insomma ad un passaggio assai delicato, anzi ad un vero e proprio “redde rationem”.
Per noi questa situazione deve poter essere “coniugabile” anche con l’attuazione della riforma fiscale.
Sono mesi che chiediamo che venga dato al sistema questo - soprattutto questo - tipo di “scossa”.
Lasciamo pure perdere gli slogan, anche perché stanno diventando un po’ stucchevoli.
Diciamo, invece, che, per il Governo, è arrivato il momento “della politica del fare”.
E, per quanto ci riguarda, “fare” oggi vuol dire, in primo luogo, mantenere le promesse che sono state fatte.
Ma, in una democrazia fondata sul consenso, la mezza bottiglia vuota pesa assai di più della mezza piena.
Di cose il Governo, in questi tre anni, ne ha sicuramente fatte e nessuno di noi intende sottovalutarne il peso e il significato.
Nel trattato sulla “Metafisica dei costumi”, Emmanuel Kant sostiene “che mantenere le promesse è un principio non negoziabile, anzi è un imperativo categorico che non ammette alcun tipo di eccezione, in nessun caso”.
E aggiunge: “è vero che situazioni del tutto eccezionali come, ad esempio, gravi difficoltà economiche, potrebbero essere tratte a pretesto per non mantenere la parola data, ma cosa accadrebbe se tutti, usando questo pretesto, si comportassero in tale modo?”
Appunto, Signor Presidente del Consiglio: le tasse, le tasse e poi ancora le tasse.
Ne abbiamo parlato, anzi straparlato. Ricorda Cernobbio?
So bene quali siano oggi i suoi problemi, ma Lei deve capire anche i nostri.
Glieli ricorda anche Carlo Rossella, direttore di Panorama, che scrive: “il taglio dell’Irpef deve essere fatto subito, per decreto. Senza se e senza ma”.
Ed è, invece, sui “se” e sui “ma” che la discussione, all’interno della maggioranza, mi sembra sempre più sfilacciarsi.
Signor Presidente, so bene che, essendo il Suo un Governo di coalizione, Lei non può non tener conto anche dei pareri, delle esigenze, degli umori degli altri.
E’ però compito Suo amalgamare queste esigenze, facendo in modo che si raggiunga un risultato che non snaturi la portata e gli obiettivi della riforma fiscale.
Attendiamo su questo maggiori “lumi”.
Mi lasci però dire una cosa: quando un “contratto” viene stipulato, esso va rispettato.
Mettiamola pure così: è un fatto di “credibilità”.
Capisco. Il problema è dove e come trovare i soldi.
Nel nostro Paese è stato, del resto, sempre così.
So bene che il problema è quello di riuscire a tagliare un po’ di rami a quel “sistema” di spesa pubblica che continua a comportarsi come una centrale elettrica ad alta tensione: chi tocca i suoi fili muore.
E sono fili lunghi chilometri.
Ma allora in che cosa consiste il cambiamento se tutto, su questo versante, è destinato a restare come prima?
Sarà una proposta “balzana”, ma c’è chi, anche nel suo Governo, sostiene che l’unica soluzione possibile sia oggi quella di mettere “il carro davanti ai buoi”.
Come? Cominciando col ridurre le tasse in maniera da essere poi “obbligati”, per far fronte agli oneri che questa decisione comporta, a tagliare le spese.
E’ come l’uovo di Colombo.
Anzi, come l’uovo e la gallina.
Come potranno crescere, d’altra parte, i consumi se non si metteranno – anche attraverso la riduzione della pressione fiscale - più soldi in tasca alle famiglie?
Come potranno crescere ed investire le imprese del terziario di mercato, se lo Stato e gli Enti locali - per tasse, imposte, costi dei servizi di base e altro - continueranno a prelevare gran parte dei loro redditi?
E come faranno le imprese italiane del turismo, che risentono della sperequazione delle aliquote IVA rispetto ad importanti competitori europei, ad “intercettare” i milioni di cinesi che presto voleranno, anche come turisti, verso il Vecchio Continente?
La riforma fiscale è la prima leva strutturale che oggi possa fare “massa critica” per la ripartenza dell’economia.
Mi creda, Signor Presidente, per ripartire va staccato questo tagliando.
Milioni di formiche e di api operaie - quelle descritte da Darwin - sono davvero stanche di lavorare, giorno e notte, per restituire poi allo Stato gran parte dei frutti del loro lavoro.
Del resto, la promessa di una riforma fiscale è stata la vera ragione, nel 2001, del successo elettorale della coalizione attualmente al Governo.
Le imprese del terziario di mercato sono una grande risorsa per le casse dello Stato.
Senza il loro apporto, avremmo anche un Pil “dimezzato”.
Ma molte di esse, le più piccole, vivono ormai come “Gli accampati di Silverado” descritti da Robert Louis Stevenson: tra fabbriche in disuso, sentieri scoscesi e serpenti a sonagli.
Non vorrei tanto soffermarmi sugli effetti perniciosi che sta avendo il processo di de-industrializzazione, in atto ormai da tempo, quanto, piuttosto, parlare dei sentieri davvero scoscesi: la cronica mancanza di infrastrutture e di servizi su cui l’imprenditore deve oggi cercare di arrampicarsi.
E vengo ai serpenti a sonagli.
Forse che le insidie rappresentate dalla vecchia burocrazia, dal dilettantismo che caratterizza talvolta il modo di fare politica e dalle ideologie da salotto non sono simili al morso di questo tipo di serpenti?
Non è un “bel vivere”, mi creda, Signor Presidente del Consiglio.
Un anno fa, proprio in occasione di questa Assemblea, parlai di una piramide in cui la scala dei valori economici si stava rovesciando: sopra i servizi, sotto l’industria.
Tutto il contrario di quel che avveniva, in questa piramide, fino a qualche lustro fa.
Altrove, direi ovunque, questa piramide si è ormai definitivamente rovesciata.
In Italia, è rimasta, invece, appesa nel vuoto: non si trova più nella posizione di prima, non si trova ancora nella posizione in cui dovrebbe stare.
E’ anche nostro compito – compito di Confcommercio – contribuire al completamento del rovesciamento della piramide, costruendo una prospettiva e una proposta associativa di riferimento per tutto il sistema dei servizi: una nuova “casa comune” delle imprese italiane dei servizi e delle loro Associazioni.
Il nostro Paese sta perdendo colpi.
Parlano numeri e statistiche.
Secondo le stime fatte dal “World Economic Forum”, relativamente all’avvicinamento agli obiettivi di Lisbona, l’Italia - per competitività, innovazione ed infrastrutture - è oggi scesa, in Europa, al 13° posto su 15.
Solo Grecia e Portogallo le stanno ancora dietro.
Non convince questa graduatoria?
E allora prendiamone pure un’altra, quella che misura la “competitività come Paese”, cioè la capacità di generare sviluppo e di garantire, al tempo stesso, un benessere crescente alla generalità dei suoi cittadini.
Secondo le stime del “Growth Competitiveness Index”, siamo, da questo punto di vista, al 41° posto. Anche Cile e Tunisia stanno meglio di noi.
Non sorprendono, dunque, le difficoltà dell’export italiano nel mondo.
Alle quali bisogna reagire valorizzando e tutelando i marchi, ma soprattutto facendo leva sui valori competitivi dell’ “italian way of life”, che è la nostra vera e unica grande risorsa.
Se poi parliamo dell’efficienza delle istituzioni pubbliche, scendiamo al 46° posto e al 44° per quanto riguarda il progresso tecnologico.
Insomma, nel complesso, non bene.
Direi, anzi, piuttosto male.
So di toccare un’altra “gengiva infiammata” parlando, in questo contesto, anche della riforma federalista.
Dico subito che - a differenza di alcuni ma, invece, come molti altri - continuo a non avere su questa “riforma” idee molto chiare.
La prima cosa da sapere è quanto essa potrà davvero costare.
Ma del progetto di federalismo fiscale, muro portante di questa riforma, non c’è ancora traccia.
E come facciamo a discutere sulla congruità strategica e sulla affidabilità di questa riforma se non si sa ancora quanto costerà, come la si pagherà e soprattutto come, in concreto, verranno ridistribuite, per farla funzionare, le risorse di cui dispone oggi lo Stato?
Il timore che questa riforma - di per sé auspicabile perché, così com’è, lo Stato centrale certo non funziona - possa comportare qualche altro guaio per il contribuente non mi pare, allo stato delle cose, né pretestuoso, né illogico, né illegittimo.
Con una domanda aggiuntiva.
Chi sta pensando alla formazione dei quadri dirigenti nella nuova burocrazia federalista?
Ci sono, certo, amministrazioni regionali già da tempo addestrate a svolgere importanti funzioni.
Ma non ci illudiamo sul fatto che una vera riforma federalista possa essere realizzata semplicemente trasferendo i dipendenti pubblici da Roma al territorio.
C’è, anzi, il rischio – e a me pare sinceramente che ci sia – che, invece, di un trasferimento, si possa andare verso il “raddoppio” del totale degli addetti della pubblica amministrazione.
Insomma quelli che ci sono più quelli che verranno.
E vogliamo parlare poi delle difficoltà che incontra il tentativo di “sradicare” la vecchia pianta del clientelismo?
E’ una pianta che appare, come dire, assai resistente alle intemperie e ai venti che pure spirano in direzione del rinnovamento.
Signor Presidente, attendiamo dunque lumi su quel che soprattutto Lei intende realmente fare: tanto per il federalismo, quanto per la riforma fiscale.
E – su quest’ultimo tema - Le anticipiamo subito che un intervento che fosse mirato al superamento dell’Irap soltanto per la “ricerca” ci convince assai poco, anzi per nulla.
Questa imposta che, assumendo nella base imponibile il costo del lavoro, penalizza paradossalmente le imprese che più contribuiscono all’occupazione va soppressa – gradualmente magari, ma “inesorabilmente” – per tutte le imprese.
Intendo dire che va soppressa:
- per le poche cui è riservato per legge il sostegno dei fondi pubblici alla ricerca;
- per le molte altre che, di tasca propria, si misurano con l’innovazione di prodotto e di processo;
- per le tantissime che, tirando la “carretta”, hanno consentito che l’occupazione crescesse in questo Paese anche in anni di congiuntura difficile.
Se no, Signor Presidente, sono solo chiacchiere.
L’occupazione è cresciuta anche grazie ad un più flessibile mercato del lavoro, che attende però ancora un rinnovato e coerente apparato di ammortizzatori sociali.
Torno alle tasse.
Quanto all’Irpef, c’è chi sostiene che il primo problema sia oggi quello di tutelare i livelli salariali dei lavoratori dipendenti.
Persino ovvio.
Ma il miglior modo per tutelarli strutturalmente è quello di aumentare, attraverso la riforma fiscale, da un lato i soldi in tasca alle famiglie e, dall’altro, di ridurre i costi di gestione delle imprese.
Solo così, infatti, potranno ripartire i consumi e l’offerta potrà avere prezzi più competitivi.
Concludendo vorrei non lasciare margini di equivoco su questa mia esposizione.
Io qui rappresento molte centinaia di migliaia di imprese - del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti - tutte “al servizio” del Paese.
Quello che ho detto fino ad ora, l’ho detto con la loro testa e con il mio cuore.
E queste imprese continuano a pensare che, nonostante tutto, possiamo farcela.
La loro testa e il mio cuore dicono però che bisogna fare di più e di meglio per evitare che questo Paese vada alla deriva.
Che possa essere una deriva di tipo argentino o di altro conio poco importa.
Il problema è che oggi questo rischio di “deriva” c’è e va contrastato in tutti i modi.
La globalizzazione sta togliendo ai mercati ogni tipo di protezione.
La competizione, in ogni area del mondo, sta diventando sempre più intensa, quasi selvaggia.
L’Europa a 25, eliminando progressivamente anche barriere fisiche, storiche e culturali, immetterà presto, anche sul mercato europeo, dosi massicce di competitività a basso costo.
Questa Europa ha ora una Costituzione, per quanto imperfetta e criticabile. Ma, accanto alla governance istituzionale, questa Europa ha urgente bisogno di governance economica.
Senza la quale – io credo – continueremo a lagnarci dell’attendismo della BCE e a invocare letture più espansive e qualitative dei parametri del Patto di stabilità e crescita.
Senza che, però, alle critiche e agli appelli, facciano poi seguito decisioni e comportamenti coerenti.
Di fronte a questi eventi che non esito a definire “storici”, un Paese potrà continuare ad essere competitivo solo se tutti sapranno fare “sistema”: lo Stato, la finanza, l’industria e i servizi.
Vogliamo cominciare ad affrontare, con diverso spirito e con maggiore senso della concretezza, tutti questi problemi o preferiamo, invece, continuare a crogiolarci nell’idea, anzi nell’illusione, che il bambino della ripresa lo possa portare la cicogna?
Purtroppo non è così. E sarebbe ora che ce ne rendessimo tutti conto.