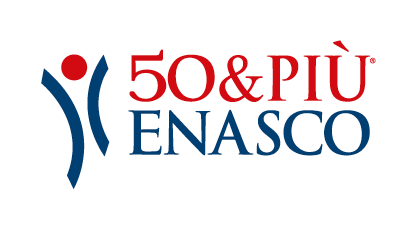La riforma del lavoro: de-regolazione o ri-regolazione?
La riforma del lavoro: de-regolazione o ri-regolazione?

Il nostro Paese si trova oggi di fronte a scenari che, sotto ogni profilo, appaiono tutt’altro che tranquillizzanti. Da qualsiasi angolo di osservazione lo si guardi questo scenario resta lo stesso. Uno scenario che potrà apparire più o meno sfumato, ma purtroppo sempre con gli stessi profili e connotati.
La verità è che non solo sembra essersi bloccato il motore dello sviluppo, ma non sembra che vi siano ancora nemmeno idee chiare né sulla reale entità del guasto né su cosa sia necessario fare per poterlo rimettere presto in moto.
Le ricette non mancano ma, essendo quasi tutte in stridente contrapposizione tra loro, finiscono con l’elidersi a vicenda sostanziando la paralisi e quindi contribuendo a prolungare la fase di stagnazione che, a sua volta, rischia di creare significativi e preoccupanti presupposti per un riflusso dell’intero sistema.
E l’incarnato di questa situazione è rappresentato dalla crisi di fiducia sulle prospettive di ripresa che ha colpito sia il mondo delle imprese che quello dei lavoratori. E non poteva che essere così perché, come dice un vecchio adagio giapponese, “quando non c’è più acqua nel secchio, non può più esserci luna nell’acqua”. Il che, tradotto, significa che se vengono meno le certezze di prospettiva, viene meno anche la fiducia con tutto quel che ne consegue.
E siccome mi pare ormai chiaro che non potranno essere né l’Europa, né gli Stati Uniti né le Nazioni Unite a risolvere un problema del genere, sarà bene che ci diamo subito tutti da fare, in un modo o nell’altro, perché il tempo davvero stringe. E stringe drammaticamente perché questa crisi endemica del sistema che ora si va a sovrapporre alle nuove, reiterate e forse più incombenti e più dirette minacce del terrorismo islamico ed anche all’improvvisa riesplosione della guerra etnica in Kosovo rischia di trasformarsi in una miscela esplosiva.
Gli aspetti più preoccupanti di questa situazione mi sembrano tre e, fra loro, abbastanza interdipendenti.
Il primo è l’ormai più che palpabile disorientamento delle famiglie a causa sia dell’erosione del loro potere di acquisto sia della perdita di credibilità, a seguito delle note vicende, del sistema di controlli a tutela e garanzia del risparmio.
O si porrà rimedio - e con misure di tempestiva efficacia - ad entrambi questi problemi o mercato cioè consumi, da un lato, ed investimenti, dall’altro, subiranno danni gravi per il sistema che, nel medio periodo, potranno diventare forse anche irreparabili.
Il secondo è il decadimento biologico di una parte del nostro sistema industriale. Tutti ci auguriamo naturalmente che esso possa riacquistare vitalità e competitività, ma non è certo somministrando solo enzimi estratti dalla papaia che si può invertire questo processo. Così lo si potrà forse ritardare, e neanche di tanto, ma niente di più.
La verità – e sono anni che lo andiamo, spesso inutilmente, ripetendo - è che bisogna lavorare ad un nuovo modello di sistema che faccia maggiormente leva su quei settori di impresa - ad esempio, quelli che operano nella grande area dei servizi di mercato - che oggi, assai più di altri, sono in grado di produrre vero valore aggiunto e nuova occupazione.
Ed è appunto questo salto di corsia, supportato da una diversa logica nella distribuzione degli incentivi e delle risorse, che potrebbe produrre un’inversione di rotta a beneficio anche – e non sembri un paradosso perché proprio non lo è - di quel comparto industriale oggi chiaramente in affanno soprattutto dal punto di vista occupazionale.
Il terzo – e siamo così al tema centrale di questo convegno - riguarda proprio le politiche del lavoro che, viste le altre due premesse, non potranno essere più quelle di prima ma dovranno adeguarsi, invece, ad un modello di sistema che, rispetto a quello degli anni ottanta e di parte degli anni novanta, sta cambiando strutture, assetti, modalità di sviluppo, cornici e contorni.
Mi sembra significativo che anche un autorevole, attento e spesso anche critico analista delle questioni del lavoro come Luciano Gallino riconosca che la flessibilità è ormai un dato strutturale di lungo periodo con il quale non possiamo più non fare i conti se vogliamo ridare slancio al nostro sistema e non operare solo nel segno del “down-sizing” del nostro posizionamento nel contesto della competizione globale.
Il primo passo è allora quello di distinguere tra la flessibilità quantitativa - che, cioè, lavora sulle connessioni tra quantità dell’occupazione e andamento del ciclo produttivo – e flessibilità qualitativa, quella che, invece, opera sulle articolazioni salariali, sugli orari di lavoro, su modalità ampie e differenziate di organizzazione del ciclo produttivo.
E distinguere ancora, dal punto di vista degli impatti, tra settori, tra contesti produttivi (ad alta o bassa intensità di lavoro e ad alto o basso grado di innovazione tecnologica) e poi tra soggetti coinvolti (i giovani, le donne) e poi ancora tra mercati territoriali del lavoro. Il che vuol dire, nella sostanza, distinguere tra la flessibilità che può essere governata per via di norme o di accordi contrattuali e la flessibilità che, per combattere il grande mercato nero dell’occupazione - un primato che nessuno, in Europa, ci invidia - richiede, invece, tutt’altra strategia.
Su entrambe queste sponde occorrono interventi che consentano di costruire una flessibilità regolamentata, contrattata ma anche sostenibile, una flessibilità cioè che sia governata in modo da assicurare, da un lato, una salda tutela dei diritti e, dall’altro, assicuri anche una progressiva ritirata della normazione dal sistema dei rapporti di lavoro.
La risposta sta probabilmente in un rapido arricchimento delle connotazioni regolamentari e istituzionali della contrattazione collettiva ed innanzitutto di quella di livello nazionale. La risposta sta anche nell’affrontare finalmente il problema della rappresentanza e della rappresentatività oggi supportato da norme di scarsa efficacia.
E vengo al punto, cioè alla riforma Biagi.
Io credo che essa possa diventare uno strumento attivo di governo della flessibilità e spero che i fatti convalidino questo mio ottimismo.
Ma non si tratta di realizzare solo una più ragionata flessibilità del mercato del lavoro già di per se rilevante, ma anche di adottare strategie che, puntando ad una flessibilità strutturale e di ambiente economico, sappiano coniugare insieme politiche macroeconomiche, crescita dell’occupazione, efficienza del mercato, formazione, ricerca, maggiore tutela dei redditi dei lavoratori e quindi migliore qualità della vita per tutti.
Insomma la riforma Biagi è solo un piccolo pezzo del grande puzzle che dobbiamo comporre per ridare slancio, su basi strutturali, a tutto il nostro sistema economico.
Occorre fare ancora ben altro e chi è oggi di parere diverso si fa solo delle pie illusioni. Bisogna far partorire al più presto nuovi modelli di sviluppo e agire il più in fretta possibile come fa l’ostetrica quando si accorge che il bambino, restando ancora nel ventre della partoriente, sta rischiando, per mancanza di ossigeno, di perdere le funzioni vitali.
E mi sembra che ci siano inderogabili priorità da affrontare. La prima è una diversa politica fiscale che sia di incentivo e di stimolo non solo per un rilancio dei consumi delle famiglie ma anche per gli investimenti delle imprese. Le une e le altre vivono al buio in un’eclisse solare che dura ormai da troppo tempo. Anni.
La seconda è la riaffermazione di una centralità della politica dei redditi come strumento di governo delle tendenze inflazionistiche. Credo che, da questo punto di vista, occorra mettere al più presto mano ad una sorta di manutenzione straordinaria del modello che ci è stato consegnato dagli accordi del luglio ’93. E ciò è possibile affidando alle parti sociali il compito di individuare percorsi e procedure che possano dare più concreta efficacia e diffusione alle intese contrattuali anche attraverso una maggiore adesione alle condizioni reali del mercato del lavoro che oggi, sul territorio, appaiono spesso assai differenziate. La bilateralità può e deve svolgere un ruolo importante in questa partita ma può e deve farlo non tanto sulla base di automatismi normativi - che pure ci vogliono ma da soli non bastano - quanto e soprattutto agendo, sul territorio, come canale attraverso il quale monitorare punti di tenuta e di crisi dei sistemi contrattuali.
La terza, che poi può considerarsi anche la premessa delle altre due, riaprire una fase di concertazione tra Governo e parti sociali che consentendo finalmente un confronto, sotto pelle, dei problemi che incontra tutto il nostro sistema economico, permetta l’assunzione di iniziative che siano il più possibile condivise.
Perché - e concludo - “o si cambia o si cambia”. Questo è quel che oggi chiede il Paese.